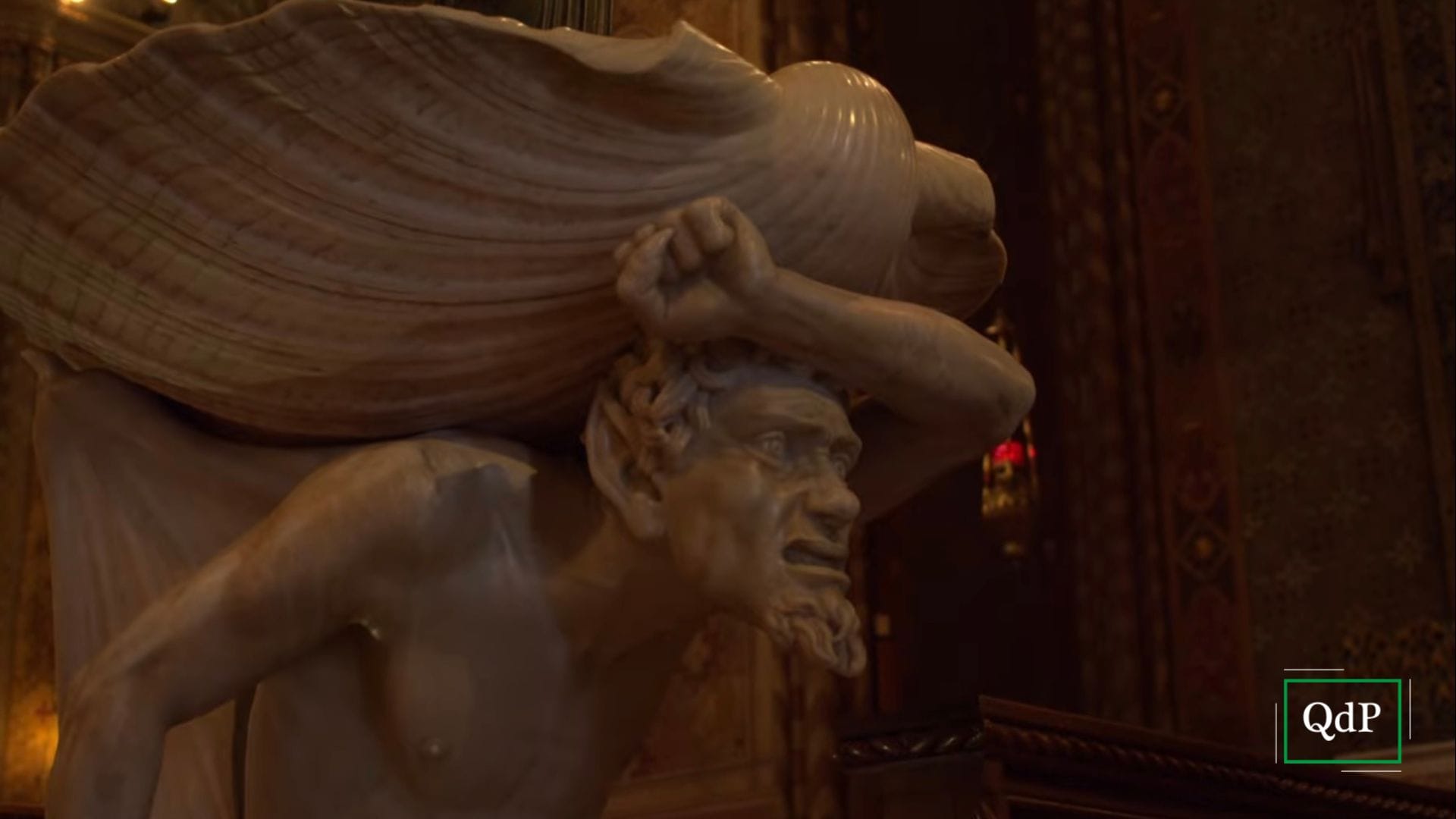Il Veneto e in particolare la Marca Trevigiana sono terre di castelli: Asolo, Conegliano, San Salvatore a Susegana, Castelbrando a Cison di Valmarino, San Martino a Ceneda, le Torri di Credazzo a Farra di Soligo sono soltanto alcuni esempi.
Simbolo indiscusso dell’età medievale, il castello evoca l’epopea delle nobili famiglie protagoniste di lotte cruente per il dominio del territorio, i fasti di corte, i tornei cavallereschi e la miserevole condizione di coloro i quali, sottomessi a tirannici feudatari, sopravvivevano all’ombra delle mura merlate.
Quando, a partire dal Trecento, i ceti più abbienti preferirono dedicarsi alle attività mercantili piuttosto che rischiare la pelle in scontri logoranti e dall’esito incerto, sui campi di battaglia della Penisola si affermarono le compagnie di ventura, formazioni di mercenari che mettevano a disposizione dei potenti la loro esperienza nel mestiere delle armi. A guidare queste milizie erano uomini leggendari e spregiudicati del calibro di Muzio Attendolo Sforza, Erasmo da Narni detto il Gattamelata, Bartolomeo Colleoni, Niccolò Fortebraccio, Giovanni dalle Bande Nere per i quali, la guerra, rappresentava non solo una lucrosa opportunità di vita, ma anche l’occasione per risalire a grandi passi la scala sociale.
Non era raro che i principi, gli imperatori e lo stesso pontefice, ricompensassero i condottieri con la concessione di titoli e privilegi in vece del denaro contante. È ciò che accadde il 28 febbraio 1436 a Conte de Brandoli investito dalla Serenissima, assieme al Gattamelata, della contea di Valmarino e della gastaldia di Solighetto: Venezia, i cui forzieri si stavano svuotando per la costosa lotta contro il Turco e l’altrettanto onerosa espansione in Terraferma, ricorse a questo stratagemma per ricompensare i due capitani per il loro “egregio e notabile servizio”.
La cerimonia di investitura, nei secoli XI – XIII, suggellava attraverso una solenne ritualità il formale patto fra il cavaliere e il suo signore. Ricevute armi e cavalcatura, il cavaliere entrava a far parte di una società che poggiava su valori quali coraggio, fede, lealtà e generosità. La massima espressione di questa elitaria comunità furono gli ordini religioso-militari fra i quali il più noto fu quello dei Templari.
La cerimonia d’investitura veniva celebrata solitamente in un castello o in una chiesa e in un momento dell’anno significativo come la Pasqua o il Natale. L’aspirante cavaliere, prima della solenne imposizione della spada sul capo e sulla spalla, doveva sottoporsi a un bagno purificatore, osservare un digiuno e trascorrere una veglia di preghiera e meditazione con indosso una veste candida simbolo di purezza e di rinascita. Da qui pare sia nata l’espressione “passare la notte in bianco”, intesa non solo come “veglia d’armi”, ma anche come sinonimo di notte insonne.
Utilizzata da Italo Calvino nel romanzo Il visconte dimezzato, l’espressione “notte in bianco” o “notte bianca” ha avuto tale successo da ispirare opere letterarie, eventi culturali e brani musicali il cui denominatore comune è trascorrere una nottata priva di sonno.
Le notti bianche è anche il titolo di un celebre racconto di Fëdor Dostoevskij ambientato a San Pietroburgo. Affascinato dal cielo lattiginoso delle notti boreali, l’autore scrive: “Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani, caro lettore. Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso, che a guardarlo veniva da chiedersi: è mai possibile che vi sia sotto questo cielo gente collerica e capricciosa?”.
La risposta a questo dilemma potrebbe essere un pensiero di Woody Allen: “Il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio ma i cattivi da svegli si divertono di più”.
(Autore: Marcello Marzani)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata