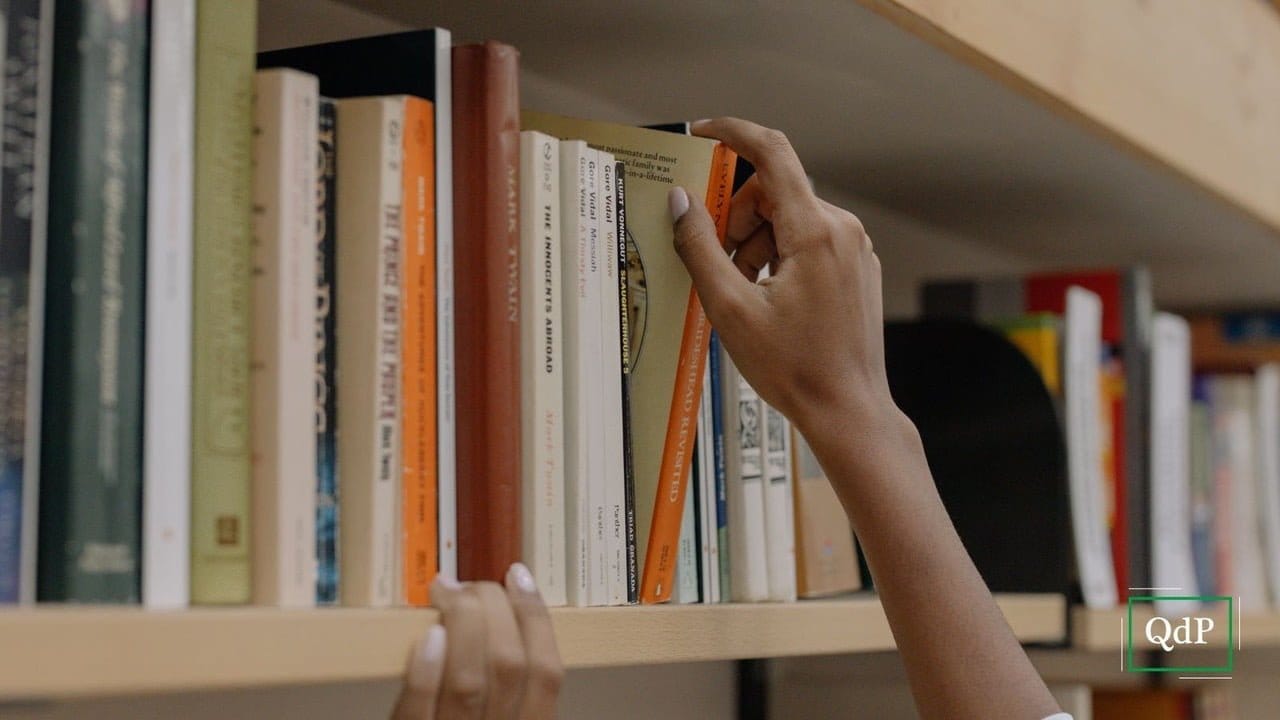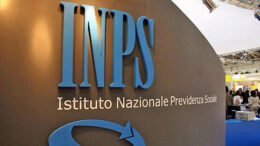È legittimo estendere l’accertamento ai conti personali del socio-amministratore unico se vi è piena sovrapposizione tra lui e la società.
È legittima l’estensione del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria ai conti correnti personali dell’amministratore e socio unico di una società di capitali, qualora emerga una sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e sociali. In questo caso, l’Ufficio può riferire alla società le movimentazioni riscontrate su tali conti, qualora vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti che le riconducano all’attività imprenditoriale dell’ente. È questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 25.06.2025, n. 17108.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a una Srl in liquidazione un maggior reddito d’impresa per l’anno 2011, derivante da operazioni finanziarie effettuate dal socio e amministratore unico sul proprio conto corrente personale acceso presso un istituto austriaco. In particolare le operazioni in questione consistevano in un versamento di 331.000 euro e in un successivo prelievo in contanti di 470.000 euro, con ulteriori 2 versamenti da 100.000 di euro ciascuno fatti nell’anno 2012.
L’Amministrazione Finanziaria qualificava queste somme come ricavi non dichiarati, operando una ripresa ai fini Ires, Iva e ritenute Irpef.
La contribuente e il suo amministratore impugnavano gli avvisi, sostenendo che le somme in questione derivavano da operazioni immobiliari di una società austriaca, di cui il soggetto era socio e coamministratore. A sostegno di questa tesi veniva evocata l’esistenza di una cassetta di sicurezza condivisa tra l’amministratore e un altro socio della società austriaca, accessibile in corrispondenza dei movimenti sul conto corrente.
Nel confermare le conclusioni espresse dalla C.T.R. del Trentino-Alto Adige, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’assenza di elementi sufficienti e idonei a dimostrare la riconducibilità delle somme alla società estera. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come la posizione del soggetto (al tempo stesso socio unico e amministratore unico della Srl) configurasse una piena identificazione tra persona fisica e società, tale da giustificare l’estensione del potere accertativo ai sensi dell’art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973.
La Corte ha altresì respinto la tesi difensiva facente riferimento all’esistenza di una pluralità di società amministrate o partecipate dall’imprenditore, chiarendo che solo nella Srl lo stesso cumulava un controllo totale, idoneo a giustificare la riferibilità delle somme contestate. Viceversa, secondo i giudici, né la società austriaca né le altre società italiane presentavano, una situazione simile, mancando la coincidenza soggettiva tra proprietà e gestione. Peraltro, in questo contesto, la cassetta di sicurezza (cointestata ad altro socio e priva di elementi documentali significativi) non è stata considerata un elemento probante della tesi difensiva.
Al contrario, l’argomentazione fondata sul concetto di “società personale” è stata considerata decisiva: infatti, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, l’assenza di terzi investitori e di altri soci avrebbe consentito all’amministratore-socio unico di poter esercitare un controllo incondizionato, rendendo plausibile l’utilizzo del conto personale per operazioni riconducibili alla gestione societaria.
Le conclusioni dell’ordinanza confermano l’orientamento ormai consolidato in materia di indagini bancarie e accertamento tributario nei confronti delle società a ristretta base partecipativa. Ancora una volta è stato ribadito che l’estensione dell’indagine al patrimonio personale del socio-amministratore non rappresenta una forzatura, ma una conseguenza logica della sovrapposizione strutturale tra società e persona fisica, allorché il soggetto concentri su di sé tutti i poteri di indirizzo e controllo. In questi casi l’onere della prova non è invertito in modo illogico dall’art. 32 D.P.R. 600/1973, ma rappresenta una naturale esigenza di difesa della capacità impositiva, rispetto a fenomeni di interposizione soggettiva che possono facilmente eludere i controlli formali. Non meno rilevante è il rigetto del motivo subordinato relativo alla deducibilità dei compensi erogati all’amministratore. La Corte ha ribadito che, ai fini della deduzione, è necessaria la delibera assembleare, espressa e documentata, ovvero la previsione statutaria (elementi non emersi nel caso concreto).
(Autore: Marco Nessi – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata