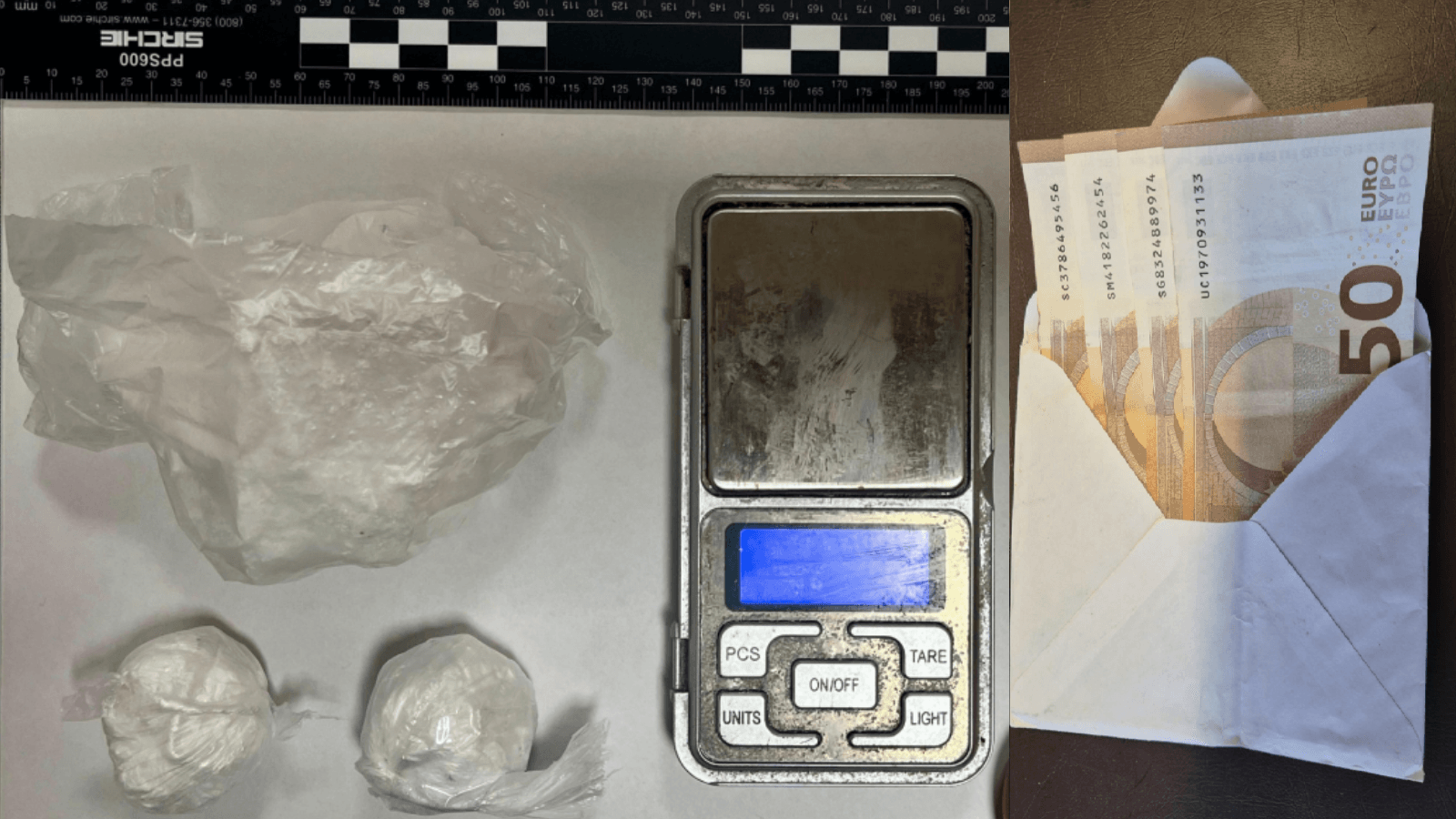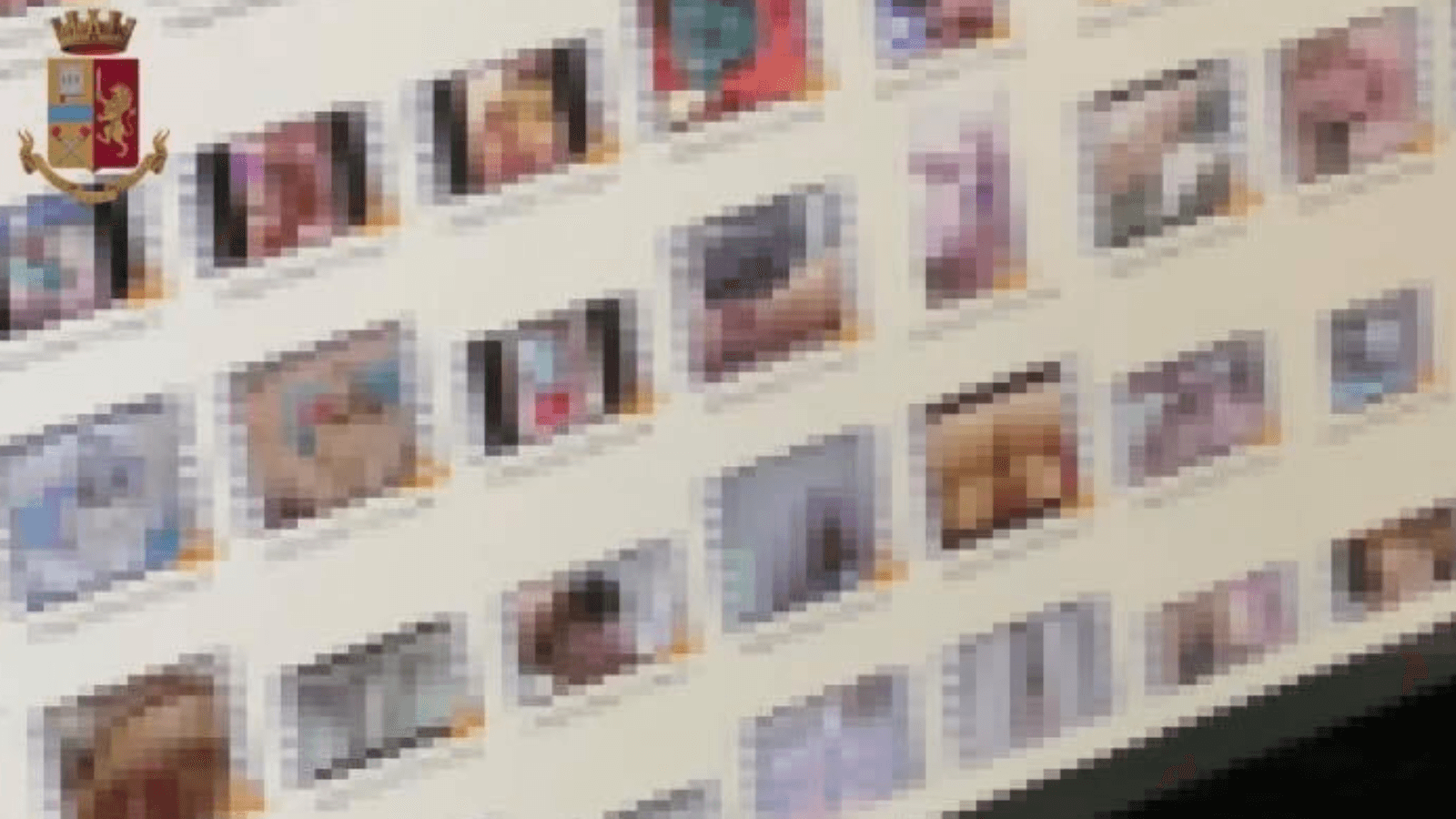Attestata indirettamente nel 1184, l’antichità della chiesa plebanale di S. Giustina di Limana è confermata dall’intitolazione a santa Giustina di Padova (I sec. d.C.), “il cui culto entrò nel Bellunese prima del Mille per l’influenza di Padova nel processo di cristianizzazione del territorio della Valbelluna” (G. Reolon).
A partire dalla reggenza di don Giovanni Pietro dalle Fossedetto Pierio Valeriano (1510-26), considerato più grande poeta e scrittore del Rinascimento Bellunese, la parrocchia di Limana venne unita per mezzo secolo al Capitolo dei Canonici di Belluno (1517-72). Secondo una consolidata prassi in uso fino al XVIII secolo, anche in questa pieve trovarono sepoltura membri delle illustri famiglie locali come Zannetta Miari (1676), Giovanni Pagani Cesa (1677), Carlo Farelli (1682), Anna Pagani (1683), Francesco Sergnano (1686), Francesco Sacello (1697), Francesco Pagani (1697). Nel 1842 il papa Gregorio XVI° donò alla parrocchia le reliquie ex ossibus di san Valentino (provenienti dal cimitero di S. Agnese di Roma), un calice d’argento (riconducibile al maestro argentiere romano Filippo Pacetti) e un piviale.
L’interno con soffitto ligneo a capriate scoperte ospita quattro altari. L’attuale altare maggiore, che era in origine quello minore dedicato alla Madonna del Rosario, mostra la tipologia strutturale ed esornativa tipica delle scuole bellunesi secentesche: alta predella con specchiature, colonne corinzie ai lati del fornice completamente irretite in una spirale di tralci di vite carichi di foglie e di grappoli d’uva, pennacchi con girali vegetomorfi, frontone triangolare spezzato, i cui settori sostengono due speculari figure allegoriche.


Contiene la pala della Madonna del Rosario tra i santi Domenico e Caterina da Siena (1634/49), ideata da Francesco Frigimelica e realizzata con la collaborazione dell’allievo Nicolò Barpi nel periodo compreso tra il 1634 e il 1649, cioè all’epoca dell’episcopato di Giovanni Tommaso Malloni, il cui stemma si riconosce sotto il piede di san Domenico. Mentre tutto il settore medio-alto della tela è attribuibile a Nicolò de Barpi in forza di un “lessico crivellato da gergalismi”, al Frigimelica si addicono le inquiete immagini delle anime, “la cui agile fattura non si coniuga con la trepida gravità di tutte le altre figure” (F. Vizzutti).
Su di un banco di turgide nubi la Vergine e il Bimbo sono raffigurati nell’atto di consegnare la corona del Rosario rispettivamente a san Domingo di Guzman e santa Caterina da Siena. Le anime del Purgatorio nei bagliori del fuoco invocano a gran voce i misericordiosi suffragi di coloro che sono ancora nel mondo. Il messaggio insito nel testo figurativo consiste dunque nel sollecitare i vivi alla confidente preghiera, la quale proprio per l’intercessione della Vergine si trasforma in atto di autentica carità (rappresentata simbolicamente dalla discesa della luminosa figurina dell’Angelo Liberatore) verso quei defunti che necessitano della purificazione per essere immessi nell’eterna beatitudine (F. Vizzutti).
La statua in legno di cirmolo policromato della Madonna Immacolata, ora collocata a sinistra dell’arcata trionfale, è un’opera di nobile impianto progettuale e sommessa eleganza compositiva e di dettaglio. Realizzata da Andrea Brustolon tra il secondo e il terzo decennio del Settecento per la villa Piloni di Limana, nel 1796 venne ceduta dalla contessa Porzia Piloni all’arciprete don Pietro Sasso per usarla nelle processioni.
(Autore: Giuliano Ros)
(Foto e video: Simone Masetto)
(Foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata