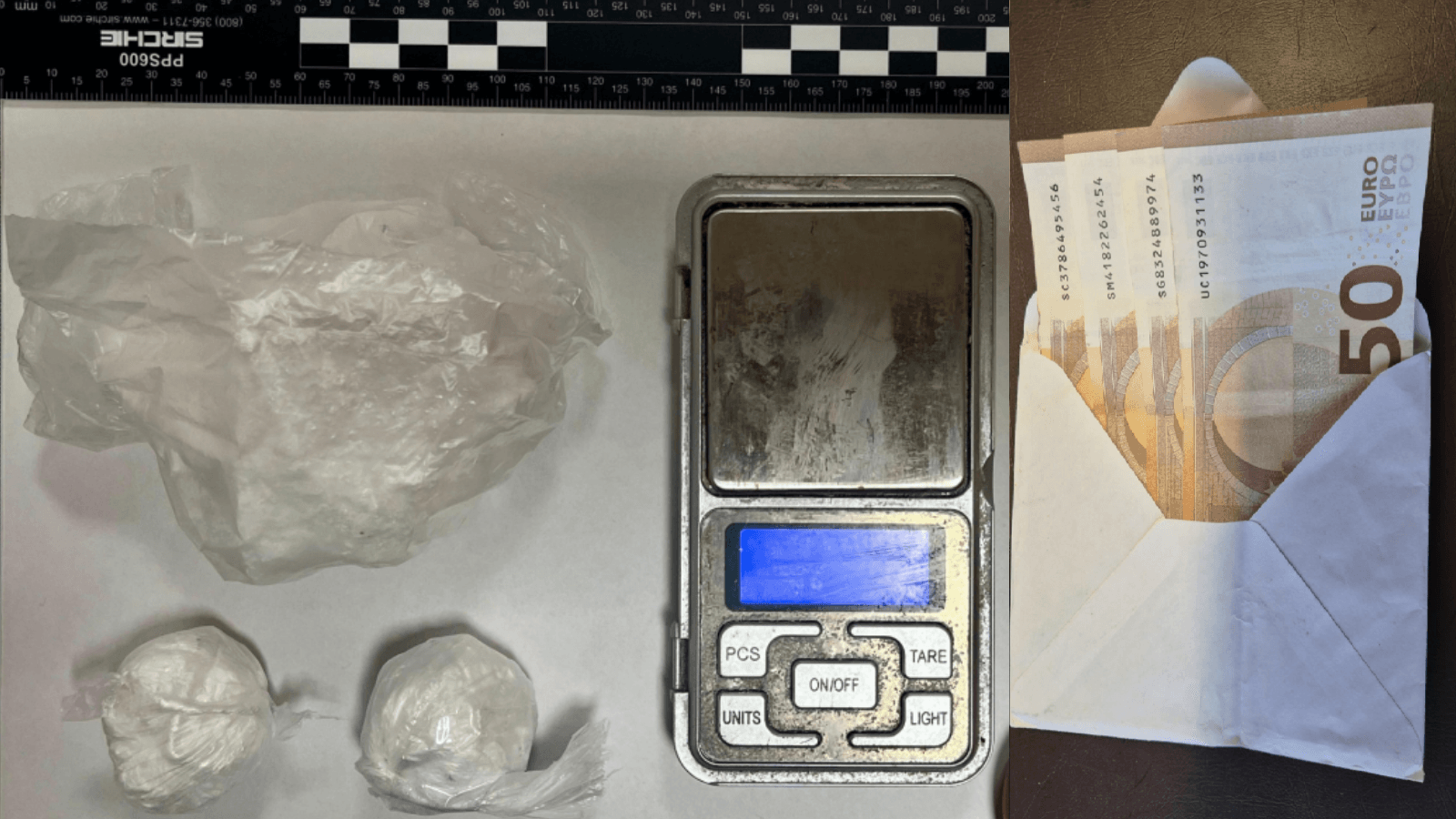La primitiva chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Giaon è citata per la prima volta nel 1570, attorniata da un cimitero (1583). Tra le suppellettili di valore tuttora conservate si annoverano un calice della Controriforma dalle “linee morbide e pulite” (T. Conte) e la pala attribuita ad Antonio Gabrieli (1780). Restaurato e benedetto nel 1896, questo edificio crollò a causa del terremoto del 1936. L’attuale chiesa fu ricostruita nel 1938 “grazie al tenace coinvolgimento degli abitanti locali”, che la hanno recentemente dotata di inferriate alle finestre e di un elegante cancello all’ingresso.
Il dipinto della Madonna Immacolata tra i santi Giacomo e Antonio Abate, racchiuso entro una cornice a edicola rinascimentale di sobria eleganza formale, “si dimostra accattivante per la fattura corsiva delle figure vitalizzate da vivide scelte cromatiche” (F. Vizzutti).


Citato per la prima volta nel 1519 il santuario di Parè, che deriva il nome dall’intitolazione a Maria “Madre di Dio” (Deiparae), è “fabricatum in radicibus montis” al termine del ripido e zigzagante sentiero della Via Crucis, punteggiato dai capitelli devozionali delle 14 stazioni, luoghi che hanno ispirato lo scrittore Dino Buzzati per il suo ultimo lavoro I miracoli della Valmorel (1971). Curato dai villici di Giaon, il santuario fu meta di pellegrinaggi, assumendo infine dignità letteraria nel romanzo storico Madonna Parè di don Giosuè Fagherazzi (1950), considerato I promessi sposi della Val Belluna.
Già nella seconda metà del XV secolo la troviamo affrescata con l’Annunciazione ai fianchi dell’arcata trionfale e il Tetramorfo nel sottarco ad opera di un artista vicino al celebre Maestro della Cappella Galletti (S. Claut). Nel 1532 la parete nord fu affrescata da Giovanni da Mel con l’Ultima Cena e la titolare Madonna con Bambino con “impianto solido e monumentale” (G. Reolon). Il piccolo dossale e il paliotto dell’altare di gusto tardo-cinquecentesco, attribuiti alla bottega di Jacopo Costantini (F. Vizzutti), si presentano di garbata esecuzione e di sorvegliata fattura.
Nella pala della Madonna in gloria sotto la Trinità e i santi Pietro, Carlo, Giovanni e Rocco (1776) Antonio Gabrieli da Belluno itera lo schema da lui già impiegato nella Madonna del Rosario realizzata per la parrocchiale di S. Bartolomeo di Arfanta. Il santuario venne ampliato nel 1842 sotto la direzione del “benemerito” cappellano don Giuseppe Sandi, che con “zelo e premura” fece anche fabbricare la sacrestia e la cella per uso d’un custode, fece erigere i quattordici capitelli della Via Crucis e chiamò Girolamo Moech da Belluno a dipingere una Crocifissione sopra l’arco trionfale e la Gloria della Vergine sul soffitto, vasto dipinto che propone nel registro più alto l’incoronazione di Maria, mentre nel registro inferiore si dipana “un sensibilissimo paesaggio vibrante nella scelta cromatica di tipo quasi calligrafico con il sentiero zigzagante che s’inerpica tra le parallele cappelline della Via Crucis, di fronte alle quali indugiano i devoti compuntamente oranti” (F. Vizzutti).
Vicino alla chiesa di riconosce la casina dell’eremita di allora, l’ascetico e povero Giacomo Tison che, benemerito per aver contribuito ai restauri della chiesa, venne ritratto da Osvaldo Monti (1847), ridisegnato da Galeazzo Monti (1853) e immortalato nel romanzo Madonna Parè di Giosuè Fagherazzi (1950). Nel 1946 le icone all’interno dei capitelli furono ridipinte da Luigi Vardanega, che ha realizzato anche altre due storie mariane sul muro affianco l’altare.
(Autore: Giuliano Ros)
(Foto e video: Simone Masetto)
(Foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata