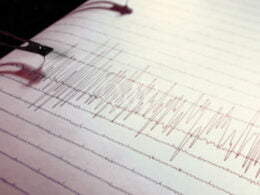Nel cuore dell’Illinois, in un campo che si estende per ettari sotto il sole estivo, cresce una pianta che sembra il “solito” mais ma non lo è del tutto. È un ibrido, un ponte tra passato e futuro dell’agricoltura, e potrebbe cambiare il modo in cui coltiviamo uno dei cereali più importanti del pianeta.
Per capire questa storia bisogna tornare indietro di migliaia di anni, quando i primi agricoltori del Messico iniziarono ad addomesticare una pianta selvatica chiamata teosinte. Era un vegetale gracile, con spighe minuscole, ben diverso dalle pannocchie generose che oggi riempiono i campi di mezzo mondo. Eppure da quella pianta modesta discende tutto il mais che conosciamo. Generazione dopo generazione, gli agricoltori selezionarono le piante più produttive, quelle con le spighe più grandi e i chicchi più numerosi. Fu un successo straordinario, ma come spesso accade quando si insegue un unico obiettivo, qualcosa andò perduto lungo la strada.
Un gruppo di ricercatori guidato da Alonso Favela dell’Università dell’Arizona e Angela Kent dell’Università dell’Illinois ha scoperto cosa abbiamo sacrificato in nome della produttività. Nel terreno che circonda le radici delle piante vive un mondo invisibile di batteri e funghi, miliardi di microrganismi che svolgono funzioni essenziali per la sopravvivenza del vegetale. Tra questi, alcuni trasformano l’azoto presente nel suolo, rendendolo disponibile per la pianta o disperdendolo nell’atmosfera. Il teosinte, la pianta selvatica da cui tutto ebbe inizio, aveva sviluppato la capacità di controllare questi microrganismi, trattenendo l’azoto nel terreno e riducendo gli sprechi. Il mais moderno ha perso questa abilità.
La scoperta è arrivata osservando cosa accade nelle radici di diverse varietà di mais e del loro antenato selvatico. Le piante non sono organismi isolati: attraverso le radici rilasciano nel terreno una miscela di sostanze chimiche, una sorta di linguaggio molecolare che attira o respinge specifici batteri. Il teosinte produce composti che tengono a bada i microrganismi responsabili della nitrificazione e della denitrificazione, due processi che trasformano l’azoto in forme che la pianta non può assorbire o che si disperdono nell’aria come gas serra. Il mais coltivato, selezionato per crescere in terreni ricchi di fertilizzanti, ha smesso di produrre queste sostanze protettive.
I ricercatori hanno utilizzato un approccio ingegnoso per recuperare i tratti perduti. Hanno lavorato con linee di mais che contenevano piccoli frammenti del genoma del teosinte inseriti nel patrimonio genetico di una varietà elite chiamata B73, una delle più utilizzate nella ricerca e nel miglioramento genetico del mais. Queste piante ibride permettono di studiare l’effetto di specifici geni selvatici in un contesto genetico moderno, come se si potesse accendere e spegnere singoli interruttori per vedere cosa cambia.
I risultati sono stati sorprendenti. Alcune linee ibride hanno mostrato una riduzione del cinquanta per cento nei tassi di nitrificazione del suolo rispetto al mais convenzionale. Altre hanno soppresso la denitrificazione di quasi il sessanta per cento. Analizzando i cromosomi responsabili di questi effetti, i ricercatori hanno identificato geni coinvolti nella produzione di metaboliti secondari, molecole che le piante sintetizzano non per crescere ma per interagire con l’ambiente circostante.
Le analisi chimiche delle radici e degli essudati radicali (le sostanze che le piante rilasciano nel terreno attraverso le radici per comunicare con i microrganismi circostanti) hanno rivelato differenze marcate tra le linee con capacità inibitoria e quelle normali. Le piante capaci di sopprimere la nitrificazione producevano meno zuccheri semplici e più composti contenenti zolfo, acidi grassi e molecole aromatiche. Alcune di queste sostanze, testate in laboratorio, hanno dimostrato di inibire l’attività dei batteri nitrificanti con un’efficacia superiore a quella degli inibitori chimici sintetici attualmente in commercio.
Il problema che questa scoperta potrebbe contribuire a risolvere ha dimensioni enormi. L’agricoltura moderna dipende dai fertilizzanti azotati per sostenere le rese elevate richieste dalla popolazione mondiale. Ma solo il trenta per cento circa dell’azoto applicato ai campi viene effettivamente assorbito dalle colture. Il resto si disperde nell’ambiente, contaminando le falde acquifere con nitrati, alimentando la proliferazione algale nei fiumi e nei mari, producendo protossido di azoto che contribuisce al riscaldamento globale. Solo negli Stati Uniti, il mais viene coltivato su quasi quaranta milioni di ettari, una superficie equivalente a quella del Montana, con circa quattromila miliardi di piante. A questa scala, anche un miglioramento modesto nell’efficienza di utilizzo dell’azoto avrebbe conseguenze significative.
La domanda cruciale era se questi tratti ancestrali potessero essere reintrodotti nelle varietà commerciali senza compromettere la produttività. I ricercatori hanno creato ibridi incrociando le linee portatrici dei geni del teosinte con altre varietà di mais, simulando il processo di sviluppo delle sementi commerciali. I risultati delle prove in campo hanno mostrato che le piante con i tratti di soppressione della nitrificazione non subivano penalità significative in termini di resa. Anzi, in condizioni di scarsa disponibilità di azoto, gli ibridi con i geni del teosinte hanno prodotto più biomassa e accumulato più azoto nei tessuti rispetto ai controlli convenzionali. In condizioni di fertilizzazione abbondante, le piante modificate hanno mostrato concentrazioni proteiche più elevate nei chicchi.
Questi risultati aprono prospettive inedite per il miglioramento genetico delle colture. Per decenni, i programmi di selezione si sono concentrati su tratti visibili e misurabili come l’altezza, la dimensione delle spighe, la resistenza alle malattie. L’idea che le piante possano essere selezionate per la loro capacità di modellare le comunità microbiche del suolo rappresenta un cambio di paradigma. I ricercatori hanno coniato il termine fenotipi associati al microbioma per descrivere queste caratteristiche ereditabili che si manifestano non nella pianta stessa ma nell’ecosistema che la circonda.
La storia del teosinte e del mais ci ricorda che l’addomesticamento ha sempre un costo. Nel perseguire obiettivi immediati come la resa e il sapore, abbiamo inconsapevolmente eliminato tratti che avrebbero potuto renderci meno dipendenti dagli input chimici. Ma la storia ci mostra anche che questo patrimonio genetico non è perduto per sempre. Nei semi conservati nelle banche del germoplasma, nelle popolazioni selvatiche che ancora crescono nelle montagne del Messico, si nascondono soluzioni a problemi che i nostri antenati non potevano prevedere.
Il lavoro di Favela, Kent e colleghi dimostra che è possibile guardare indietro per andare avanti, attingendo alla diversità genetica dei progenitori selvatici per affrontare le sfide dell’agricoltura contemporanea. Non si tratta di tornare a coltivare il teosinte, ovviamente, ma di recuperare chirurgicamente quei frammenti di DNA che codificano funzioni preziose e inserirli nel contesto delle varietà moderne. È un processo di rewilding genetico, un tentativo di restituire alle piante coltivate una parte della complessità ecologica che hanno perduto.
Le implicazioni vanno oltre il mais. Molte colture hanno parenti selvatici che potrebbero nascondere tratti simili. Il frumento ha antenati che mostrano capacità di soppressione della nitrificazione ancora più marcate di quelle del teosinte. Il riso, la soia, l’orzo potrebbero rivelare sorprese analoghe se esaminati con gli stessi strumenti. L’approccio sviluppato dai ricercatori dell’Illinois e dell’Arizona fornisce una mappa metodologica per esplorare questo territorio sconosciuto.
Resta ancora molto da capire. I meccanismi molecolari attraverso cui le piante comunicano con i batteri del suolo sono complessi e in gran parte ignoti. L’efficacia dei tratti di soppressione potrebbe variare in funzione del tipo di terreno, del clima, delle pratiche agricole. Gli esperimenti condotti finora si sono svolti in condizioni controllate e in un numero limitato di ambienti. Prima che queste scoperte possano tradursi in nuove varietà commerciali, saranno necessari anni di prove e validazioni.
Ma la direzione è tracciata. In un’epoca in cui l’agricoltura deve produrre di più con meno, riducendo il proprio impatto ambientale mentre affronta le incognite del cambiamento climatico, la possibilità di progettare colture che collaborano con il suolo invece di sfruttarlo rappresenta una prospettiva rivoluzionaria. I semi di questa rivoluzione erano già presenti, nascosti nel genoma di una pianta selvatica che i primi agricoltori del Messico iniziarono a trasformare diecimila anni fa. Ci è voluto tutto questo tempo per capire cosa stavamo perdendo. Ora, finalmente, possiamo iniziare a recuperarlo.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata