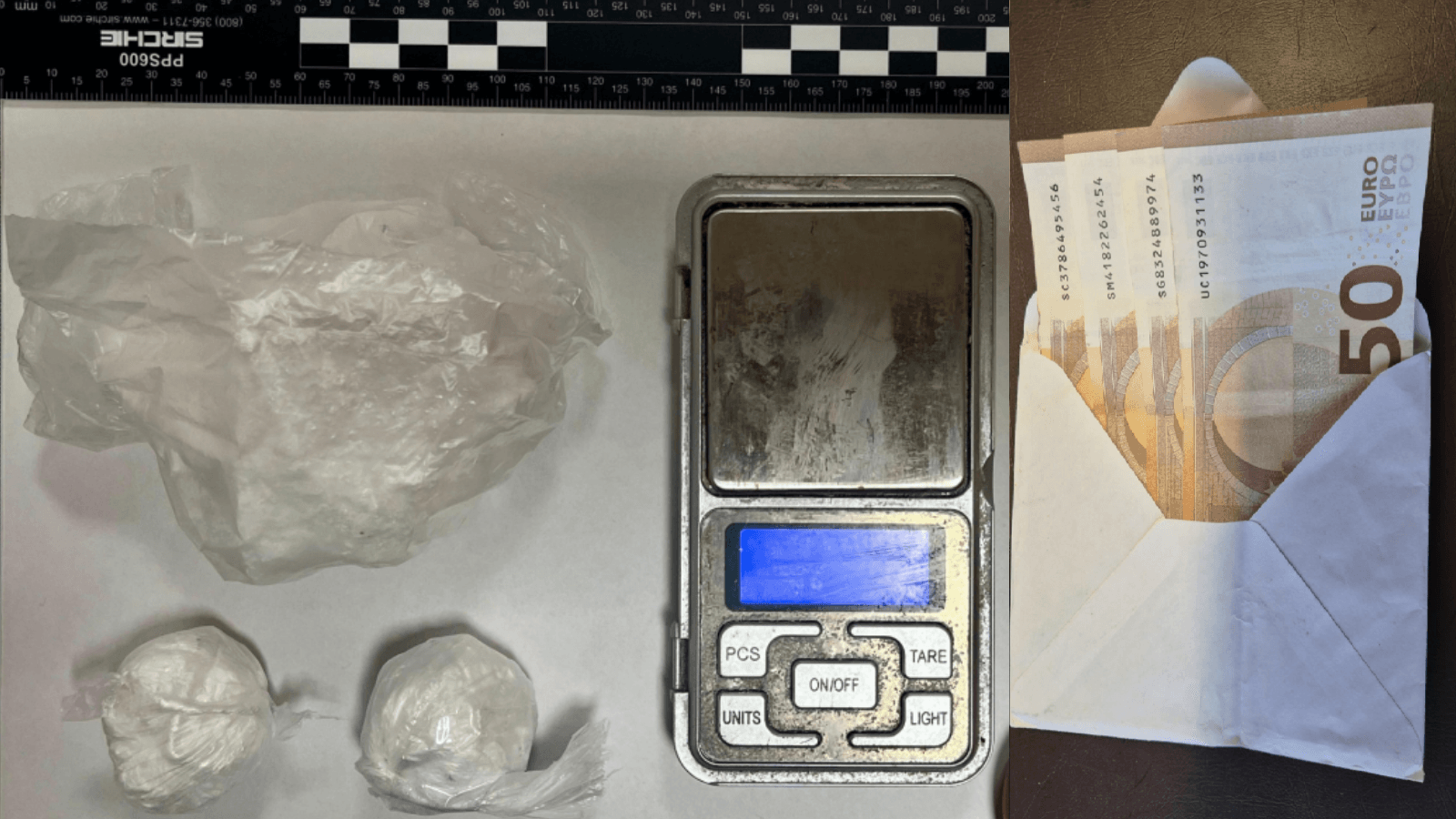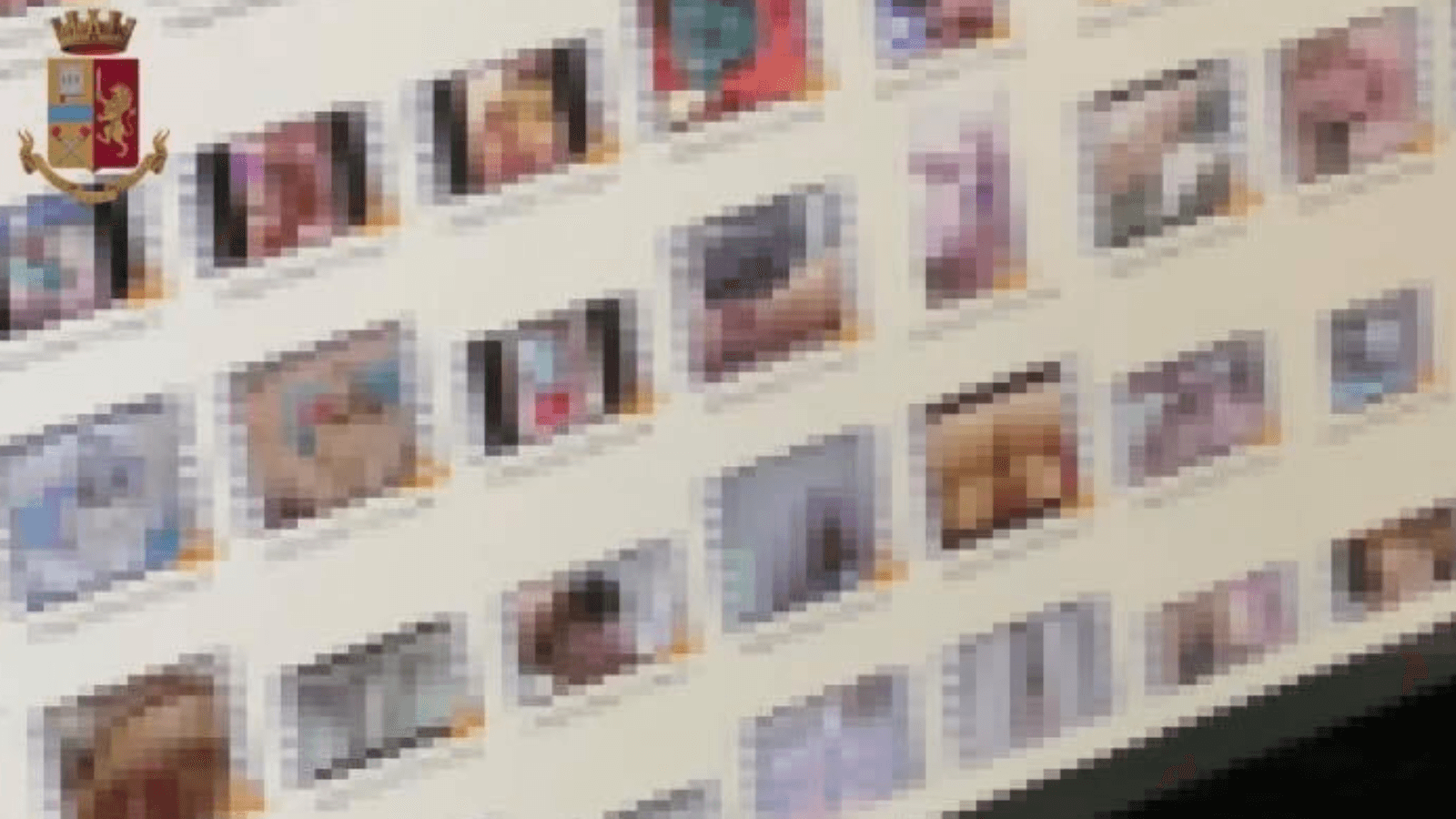L’oratorio di San Donato, con l’annesso eremo, si trova sopra l’abitato di Ronchena, in comune di Borgo Valbelluna e in parrocchia di Lentiai.
Anche se molto antico, forse di età longobarda, la prima attestazione è del 1529. L’aspetto attuale deriva da diversi interventi operati nei secoli. Il più evidente, l’innalzamento dell’edificio, nella metà del XVIII secolo.
L’oratorio-eremo è dedicato a San Donato; la devozione popolare lo lega a San Donato Vescovo e Martire di Arezzo che subì il martirio e morì decapitato il 7 agosto del 362.
Un edificio dal tipico aspetto quattrocentesco, con tetto a capanna e campaniletto a vela e ad unica navata. L’intonaco più antico risale probabilmente al XV secolo ed è presente nella parete del presbiterio con la raffigurazione di una teoria di santi e nell’aula dove sono state riportate alla luce le croci della consacrazione.
La prima figura della teoria dei santi, a sinistra, rappresenta San Vittore. La spada e la palma sono due simboli chiari del martirio di questo miles Christi.
Alla sinistra di San Vittore, entro la stessa cornice, su sfondo impreziosito da un drappo giallo con stampigliature rosse, si stacca la figura di Sant’Antonio Abate, eremita, patriarca del monachesimo, uomo di preghiera, lottatore contro i demoni, guaritore degli infermi, direttore di anime.
La Madonna è seduta in una sede forse marmorea e dalle linee essenziali. Porta manto e veste eleganti con linee morbide. Tiene in braccio Gesù e lo sostiene. L’aureola del bambino è crucifera, Egli indossa ai fianchi un perizoma e porta al collo una collana simboli di passione.
San Donato è raffigurato come vescovo in abiti pontificali, con mitra ornata in capo, casula e dalmatica pontificale. Il capo è coronato da nimbo. Che si tratti di San Donato non vi è dubbio, in quanto nella cornice superiore si legge in stampato maiuscolo la scritta “S.DON”.
San Pietro appare in dimensioni un po’ ridotte rispetto alle altre figure. È un uomo di mezza età o anziano, dai lineamenti marcati e popolani. Tiene con la mano sinistra il libro e con la destra due chiavi, una rivolta verso l’alto, l’altra verso il basso.
Nel presbiterio, sulla parete di fondo e sulla parete destra, due affreschi databili al XVII secolo.
L’affresco sulla parete di fondo potrebbe far pensare a San Bernardo di Chiaravalle, ma questa ipotesi potrebbe trovare una diversa interpretazione collegata alla presenza in loco degli eremiti dell’Ordine di Sant’Agostino. Leggendo infatti l’iscrizione ai piedi dell’affresco si ritrova il nome dell’eremita Pietro da Valdobbiadene in cui si trova l’eremo di Sant’Alberto Carmelitano o Sant’Alberto degli Abati. Nell’iconografia, Sant’Alberto degli Abati appare spesso proprio con un rametto di giglio in mano e con un libro nell’altra, con abito scuro e manto bianco.
Nella parete destra è evidente l’affresco di un altro santo in piedi; indossa una veste nera e nella mano sinistra sorregge un libro chiuso. Per la diffusa devozione popolare è stato facilmente identificato come Sant’Antonio da Padova. Ai piedi di tale riquadro però si trova l’iscrizione in cui si fa cenno e lode all’eremita Pietro di Valdobbiadene dell’Ordine degli Agostiniani. Ciò porta a supporre che l’affresco potrebbe riferirsi a Sant’Agostino, come semplice monaco agostiniano con saio nero e cintura.
In controfacciata è evidente lo stemma con ogni probabilità del Vescovo di Ceneda Marcantonio Agazzi.
Alla base della finestra si trovano un’acquasantiera a muro in pietra calcarea scolpita risalente probabilmente al XV-XVI secolo e accanto una seconda acquasantiera o una cassetta per l’elemosina.
Ben leggibile una scritta in tonalità del rosso: “MVNDA”, imperativo del verbo latino che significa pulire, cioè purificarsi con l’acqua benedetta prima di mettersi in comunione con Dio.
L’altare maggiore (XVII e il XVIII secolo) è in legno scolpito, dipinto, dorato. La mensa è piuttosto grande, con paliotto mobile (i due paliotti originari, in cuoio, del XVII-XVIII secolo sono ora conservati in altre sede). La cornice racchiude una tela di autore ignoto della fine del XVII secolo con la raffigurazione della Madonna con il Bambino in trono e i Santi Donato e Bartolomeo.
Nella parete destra la copia della tela di Luigi Cima, realizzata dal pittore locale Toni Piccolotto nel 1961, raffigurante la Madonna di Caravaggio.
Dalla chiesa o da una porticina indipendente si entra nell’eremo, formato da due piani collegati da una scala interna. Al piano terra domina una stanza adibita a cucina e al piano superiore è stata arredata una spaziosa camera con un piccolo bagno.
Dalla fine del XVII secolo alla metà del XVIII secolo è attestata la presenza degli eremiti. Per un lungo periodo furono eremiti dell’Ordine di Sant’Agostino e in seguito del Terz’Ordine Francescano. Di fondata certezza il loro legame con l’ordine degli agostiniani di Feltre del monastero di Ognissanti.
(Autore: Paola Brunello)
(Foto e video: Simone Masetto)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata