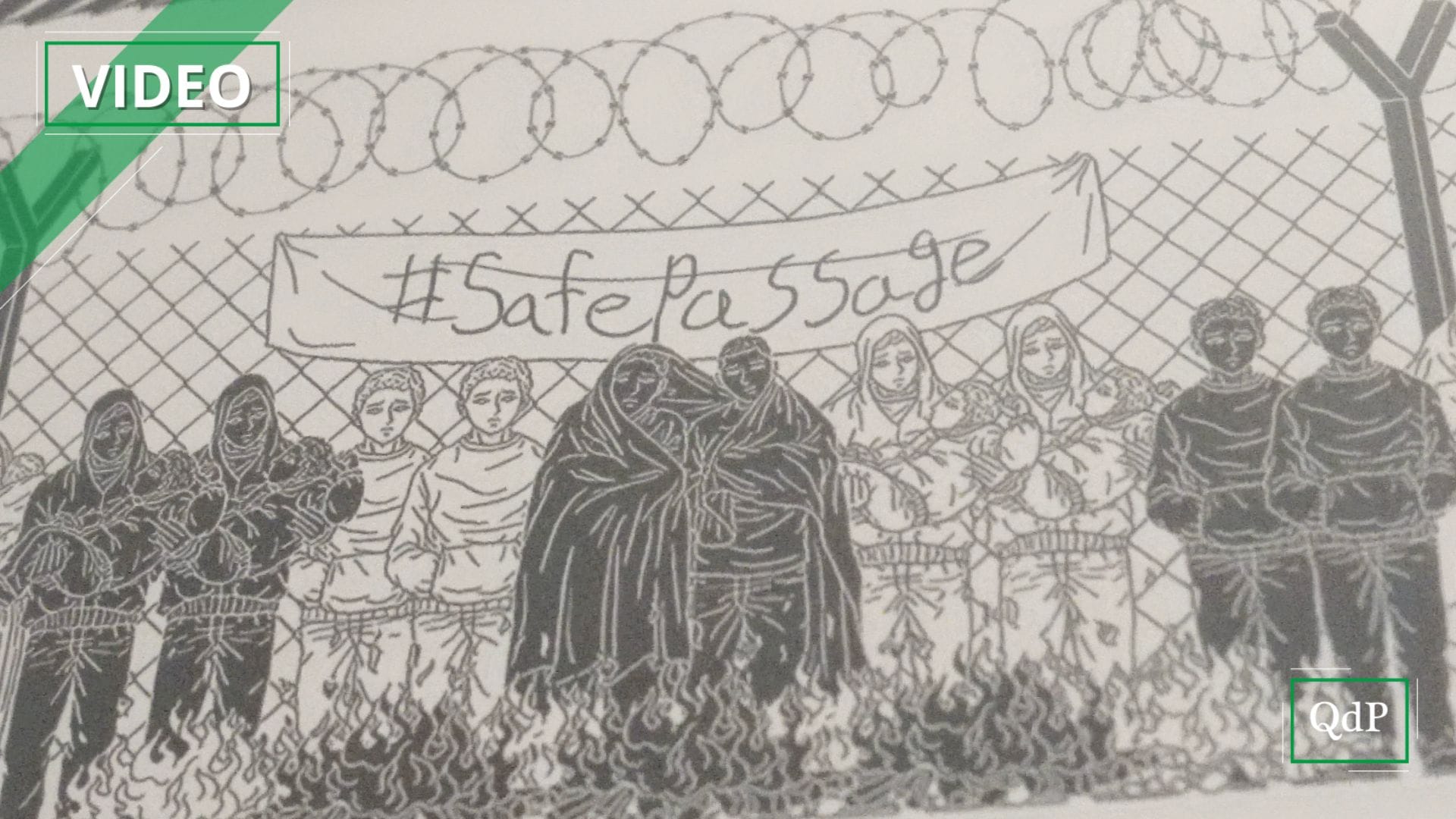Tra i vicoli di Napoli hanno luogo una serie di rapimenti misteriosi. A scomparire, vittime di un incomprensibile disegno, sono solo donne. Donne che, apparentemente, non sembrano avere alcun legame tra loro, ad eccezione dell’aspetto. Tutte hanno la pelle chiarissima e i capelli rossi: talmente belle da sembrare le protagoniste di un dipinto. Le complicate indagini vengono affidate a Viola Lunardi, brillante e carismatica sovrintendente della Polizia di Stato.
Presentato nella serata di sabato 12 luglio nell’auditorium Ascom di Oderzo – Motta di Livenza, nella città opitergina, nell’ambito dell’evento culturale “Al femminile” promosso dalla sigla di Confcommercio presieduta da Rino Rinaldi, “Il rosso e il viola”, romanzo edito da Mondadori è un giallo tutto al femminile opera prima della viterbese Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista al suo esordio nella veste di scrittrice.
Un appuntamento culturale tra letteratura e diritto, con un focus sul ruolo femminile all’interno della Costituzione repubblicana, in occasione degli ottant’anni dall’entrata in vigore della Carta.
Le donne, le loro storie, il loro ruolo nella società e le mille sfumature e accenti di cui sono portatrici sono le protagoniste assolute del romanzo della Guerrini. A fare da sfondo alla costruzione narrativa dell’autrice c’è Napoli, una città nei confronti della quale la scrittrice esordiente nutre un amore profondo: da Posillipo a Mergellina, passando per quei quartieri difficili che rendono la città partenopea “bella e dolorosa”.
“Quando ho pensato a una città nella quale ambientare il mio romanzo – racconta la Guerrini – c’erano alcuni requisiti che erano fondamentali. Doveva essere una grande città di mare, con una grande università e tante donne dai capelli rossi. Ecco, Napoli corrispondeva perfettamente a quanto stavo cercando: è una città affascinante che mi ha sempre attratto per la sua storia e le sue contraddizioni, fatte di eccessi e di straordinaria bellezza. Ho iniziato a visitarla, a studiare i quartieri e i vicoli, a parlare con i suoi abitanti, imparando a parlare e persino a scrivere in dialetto napoletano”.
Passione ma anche scelta stilistica precisa quella di costruire molti dialoghi in dialetto partenopeo: “Imparare a parlare ma soprattutto a scrivere in napoletano è stata una sfida impegnativa. All’interno del commissariato nel quale Viola lavora ho lasciato i dialoghi in italiano – spiega la Guerrini -; nella palestra dove pratica la boxe, invece, che è gestita da un portoghese napoletano, ho potuto permettermi un dialetto impreciso. Nei dialoghi tra napoletani, invece, mi sono inizialmente affidata al traduttore di Google, per poi scoprire che esiste anche un dizionario italiano – napoletano, e successivamente alla consulenza di napoletani doc. Più conoscevo Napoli è più me ne innamoravo – prosegue –, i napoletani sono un popolo a parte, con una mentalità diversa che mi piace molto. In questa città l’arte è ovunque, anche dove non te lo aspetti. Ogni vicolo è fatto di Madonne, colori e dipinti ai quali non viene data la giusta attenzione, il giusto valore. Napoli possiede una bellezza artistica capace di mescolarsi e di sovrastare condizioni di degrado urbano anche in quartieri difficili e controversi come quello di Scampia”.
A rappresentare l’universo femminile è Viola, una donna arrabbiata che porta sulle spalle il peso di appartenere a una famiglia difficile: “Mi chiedono spesso se la protagonista del mio romanzo mi somigli, e in parte la risposta è sì. Anche io come Viola sono irascibile, soprattutto sul lavoro, e molte volte vorrei trattare gli altri più duramente di quanto non faccia già – rivela la scrittrice –. Viola è una femminista, favorisce le donne e non prova nessuna stima nei confronti degli uomini: anzi, si stupisce quando i suoi sottoposti riescono a scrivere un testo di senso compiuto utilizzando in modo corretto verbi e coniugazioni. E’ una ragazza complicata, che odia le ingiustizie ed è insofferente alle regole. Le donne hanno una marcia in più, ma devono dimostrare di più. Da avvocato giuslavorista posso affermare come ancora oggi le donne in posizioni apicali debbano sempre salire tre gradini in più rispetto ai colleghi maschi. Le cose sono cambiate, ma non abbastanza”.
Centrale nella struttura narrativa de “Il Rosso e il viola” sono anche le dinamiche familiari della protagonista che, in parte, attingono alla sfera personale dell’autrice: “Anch’io provengo da una famiglia complessa, con un padre padrone e una madre vissuta nell’ombra. Dei miei fratelli sono l’unica ad aver lasciato Viterbo per trasferirmi in un’altra città. Non c’è dubbio che la famiglia di origine ti condizioni, ma è un legame che non puoi recidere. Qualche giorno fa ho presentato il mio libro a Viterbo, la mia città, e la mia famiglia era presente, anche mio padre – racconta la Guerrini che è stata giurata dell’edizione 2025 del premio Strega –; al di là dei problemi e delle incompatibilità la famiglia è sangue e radice, è l’abbraccio al quale tornare, nonostante tutto”.
Il ruolo delle donne e l’evoluzione del diritto rispetto alla figura femminile nella Costituzione è stato approfondito, a conclusione dell’evento, da Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale: “Nella storia della nostra civiltà il potere è sempre stato declinato al maschile. I grandi nomi che nei secoli hanno incarnato il potere sono di uomini: Giulio Cesare, Alessandro Magno, Napoleone. Sui troni delle dinastie che per anni hanno governato le nazioni sedevano solo uomini – spiega il costituzionalista -, le poche donne al governo erano vissute come una parentesi, un’eccezione. Persino uno dei più grandi filosofi dell’antichità, Aristotele, affermava che le donne non dovessero in alcun modo possibilità di accedere al potere. La democrazia ateniese le relegava nell’oikos, il focolare domestico, e le escludeva dalla polis: un’esclusione che caratterizza la nostra società sino alla seconda rivoluzione industriale, con le rivendicazioni delle prime operaie e il movimento per il diritto al voto delle suffragette”.
In Italia sarà la Costituzione repubblicana a scardinare questo sistema di esclusione, introducendo il suffragio universale femminile e il diritto al voto: “Durante la Guerra, le donne italiane sono state partigiane, hanno combattuto come gli uomini e hanno contribuito a liberare il Paese dall’occupazione: le istituzioni repubblicane non potevano non tenerne conto. La Costituzione dà alle donne non solo il diritto di votare ma anche quello di essere elette. L’assemblea costituente – ricorda Celotto – è composta non solo da padri ma anche da madri della Costituzione: 21 donne su 556 costituenti”.
In questi ottant’anni l’Italia è cambiata, ma la parità di genere non si è ancora compiuta del tutto compiuta: “Le donne sono arrivate ai vertici delle istituzioni e del potere, ma sono ancora viste come casi singoli e questo perché la nostra società è figlia di 3920 anni di un maschilismo assoluto. Per declinare il potere al femminile serve il contributo di tutti, anche quello degli uomini che troppo spesso rappresentano ancora un ostacolo alla libertà delle donne”.
(Autrice: Emma de Maria)
(Foto e video: Emma de Maria)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata