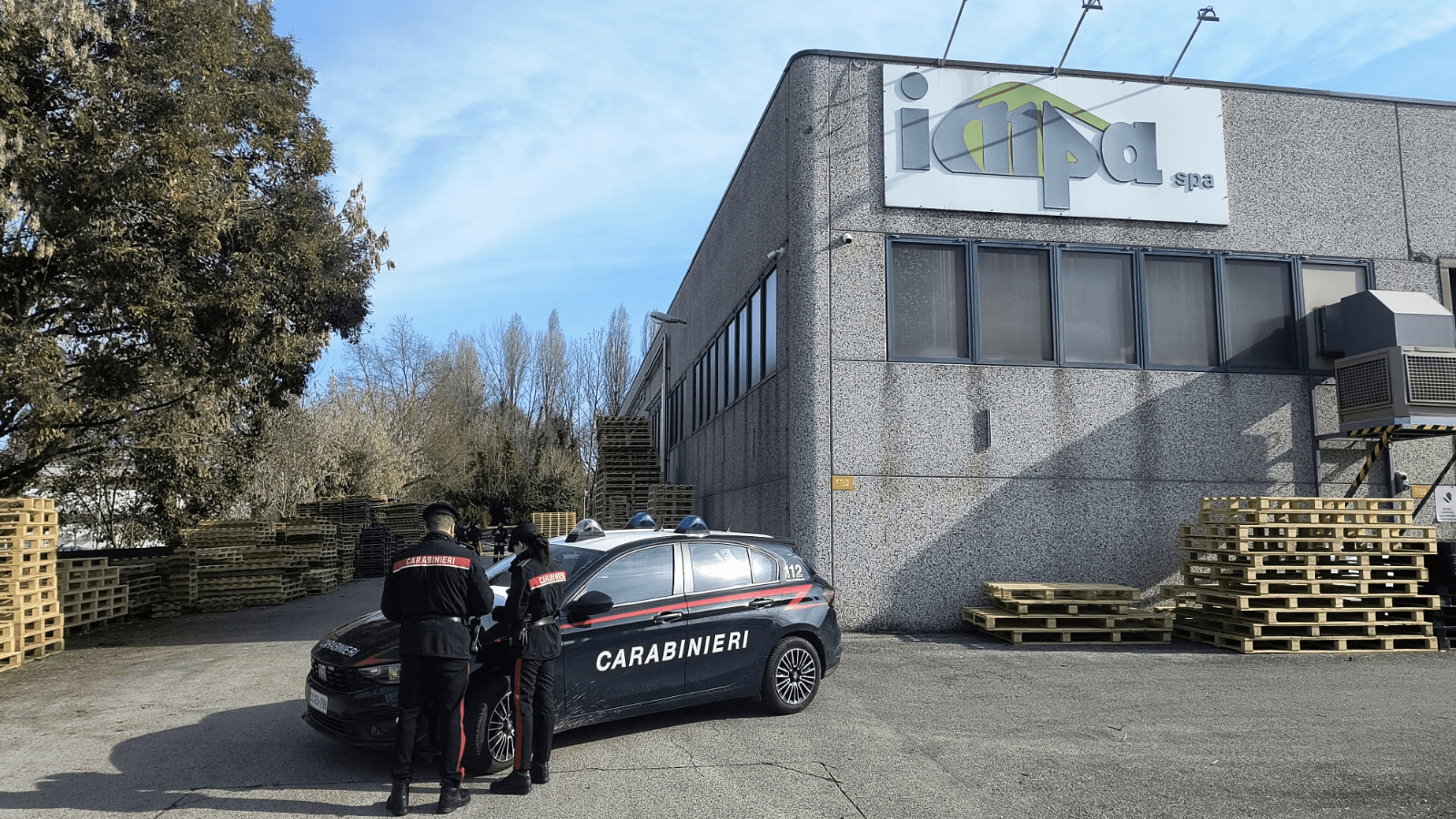Varcato il cancello del complesso di Sant’Artemio si ha l’impressione di approdare in una razionale cittadella universitaria del nord Europa: le graziose palazzine immerse nel verde, i silenziosi viali alberati sono un irresistibile invito a passeggiare lontano dal traffico e a contemplare la natura; anche l’edificio che ospita i Carabinieri specializzati nella tutela dell’ambiente e della salute emana la sobria eleganza di una dimora borghese piuttosto che la severa austerità di una caserma.
Eppure, il Sant’Artemio, oggi sede della Provincia di Treviso, soltanto pochi decenni fa era un manicomio, un’istituzione totalizzante come lo sono le carceri, i luoghi di clausura e certe strutture sanitarie in cui l’individuo, per scelta o costrizione, sperimenta il netto distacco dal mondo. Un luogo, il Sant’Artemio, nel quale migliaia di donne e di uomini hanno trascorso parte della loro esistenza lontano da una società nella quale non hanno voluto, o non hanno saputo, ritagliarsi una propria dimensione.
Decenni di sofferenza, ma anche di grande umanità, di coraggio e impegno scientifico che alla “Città del silenzio” sono valsi importanti riconoscimenti come quelli ottenuti nel 1913 all’Esposizione Internazionale d’Igiene e nel 1935 alla Mostra degli Ospedali italiani. Un nosocomio nel quale medici coraggiosi sperimentavano i farmaci sulla loro pelle prima di somministrarli agli ammalati; un luogo che tutti i trevigiani dovrebbero conoscere.
Tutto ha inizio a cavallo fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento: in Veneto imperversa la pellagra, provocata da un’alimentazione sbilanciata, carente di sale e vitamine, basata sul consumo di farina di mais spesso guasta. A farne le spese sono migliaia di contadini che la malattia aggredisce e trasforma in poveri folli. Una moltitudine di disperati che si aggiunge alle già folte schiere di epilettici, alienati, alcolisti, schizofrenici, dementi e sifilitici confinati in strutture fatiscenti, lontano dagli sguardi di una società ipocrita e bigotta.
Da questa emergenza sanitaria nasce un’inchiesta che, nel 1901, mette in risalto l’inadeguatezza dei manicomi veneziani di San Servolo (maschile) e San Clemente (femminile). Istituzioni più simili a carceri medievali che a luoghi di cura, ribattezzate emblematicamente “case del dolore”. Strutture nelle quali i malati languono nella sporcizia e nelle quali vige l’uso spregiudicato di crudeli mezzi di contenzione. Da questo clamoroso scandalo nasce l’idea di dotare anche la provincia di Treviso di un ospedale psichiatrico degno di questo nome; un istituto che faccia da capofila alle preesistenti Case di Salute di Oderzo, Montebelluna, Serravalle, Crespano e Valdobbiadene.
Da lì a pochi anni il progetto si concretizza: nel 1911 i primi 88 ammalati psichiatrici vengono trasferiti dall’ospedale civile trevigiano al Sant’Artemio, edificato in un’area verde a quattro chilometri dalla città, compresa fra la Cal di Breda, il Piavon e le risorgive dello Storga. Nel 1913 la struttura è pienamente operativa con una disponibilità di oltre trecento posti letto. L’ingegner Mussetti, il professor Antonini e il futuro direttore Zanon dal Bo sono i “padri” di un progetto estremamente ambizioso: i degenti del Sant’Artemio, oltre alla salubrità della campagna, potranno beneficiare di “acqua corrente, servizi igienici, riscaldamento con termosifoni, biblioteca, chiesetta e lavanderia a vapore“. I padiglioni, cosa affatto scontata, non avranno inferriate anche se, per ragioni di sicurezza, tavoli e panche vengono imbullonati al pavimento e l’uso di forchette e coltelli resta vietato.
Esaminando i documenti d’archivio che Paola Bruttocao e tanti appassionati come lei cercano con tenacia di sottrarre all’oblio ci si imbatte in un lessico d’altri tempi, in cui il rigore della scienza e il pragmatismo di chi, ogni giorno, ha a che fare con quelli che lo psichiatra e scrittore Mario Tobino chiamava senza falsi pudori “i matti“, si intrecciano indissolubilmente.
Scartabellando vecchi registri vergati d’inchiostro fanno capolino le migliaia di malati sottoposti al regime di osservazione e vigilanza: i tranquilli, gli agitati, gli alienati clamorosi a contegno disordinato, gli infettivi, i pericolosi e i pazienti con precedenti di giustizia. Una categoria trasversale sono i dozzinanti, malati provenienti da famiglie facoltose che, attraverso il pagamento di una retta, hanno diritto a un vitto migliore e ad alloggi sicuramente più confortevoli dei refettori e delle camerate comuni.
Accanto ai malati, nella “città del silenzio”, operano il direttore, i medici, gli infermieri, il cappellano, l’economo, l’archivista, le suore e altre figure indispensabili al funzionamento di una comunità nella quale, a dispetto di fuorvianti luoghi comuni, ci si adopera per guarire o almeno mitigare le sofferenze di ammalati e familiari.
Le terapie applicate nel manicomio sono molteplici e mutano di pari passo con i progressi della scienza medica. Talvolta si procede per tentativi, ma senza la volontà di tormentare o umiliare il malato. Se si commettono errori è per ignoranza o eccessiva fiducia nella consuetudine; non bisogna dimenticare che siamo in un’epoca in cui, all’allievo infermiere, più delle conoscenze scientifiche sono richieste “audacia agilità, energia muscolare e prontezza“.
I degenti del manicomio del Sant’Artemio sperimentano la clinoterapia, il riposo forzato, l’idroterapia, l’alternanza di bagni caldi e freddi, l’insulinoterapia e la malarioterapia consistente, quest’ultima, nell’indurre febbri altissime che avrebbero dovuto riportare i pazienti alla lucidità; si somministrazione i primi sedativi e non mancano le terribili sedute di elettroshock.
A dare maggiori soddisfazioni, soprattutto nel trattamento delle dipendenze, è l’ergoterapia, la terapia del lavoro. I settanta ettari della colonia agricola del Sant’Artemio sono una provvidenziale valvola di sfogo per migliaia di ammalati provenienti dal mondo rurale che, per quanto mentalmente fragili, sanno perfettamente come coltivare la terra o gestire una stalla. I “matti-lavoratori“, gratificati da uno stile di vita simile a quello familiare e ricompensati con un bicchiere di vino o un pacchetto di sigarette, permettono alla comunità manicomiale di sfiorare l’autosufficienza economica. Grazie alla loro abilità e alla fertilità delle terre prossime ai fontanassi, per il manicomio, vincere il primo premio alla mostra annuale dei radicchi, diviene una felice consuetudine.
In questo quadro apparentemente idilliaco, fatto anche di gite in Cansiglio, di laboratori per la lavorazione del vimini e di concerti della Schola Cantorum, non mancano tuttavia le ombre che, inevitabilmente, emergono dalla consultazione degli archivi o dall’ascolto delle testimonianze di chi, al Sant’Artemio, c’è stato davvero.
Un capitolo a sé, ad esempio, è quello dei bambini la cui presenza in manicomio resta un enigma: figli di malate giunte in stato interessante, frutto di relazioni clandestine consumate nello squallore dei padiglioni, bimbi illegittimi abbandonati da donne dell’alta società intenzionate a salvaguardare la propria reputazione? La verità su creature come Giuseppe Angelo, figlio di ignoti nato in manicomio il 17 agosto 1927 o Marino, morto nel 1920 all’età di dodici anni, per i “postumi di morsicatura di cane idrofobo” forse non la sapremo mai.
Con lo scoppio della Grande Guerra il manicomio assolve per alcuni anni le funzioni di ospedale militare di riserva e accoglie centinaia di soldati feriti nel corpo e nella mente dagli orrori del conflitto. Uomini come M.S. che “ha gli occhi sbarrati e si presenta terrorizzato da visioni di spavento” o P.B. che parla da solo, piange e si sente “distruggere come una candela” si affiancano agli altri ammalati, ampliando uno spettro di sofferenze che sembra non avere limiti.
Fra i ricoverati nell’istituto psichiatrico trevigiano non mancano alcuni artisti, il più famoso dei quali è il pittore Gino Rossi, la cui salute mentale inizia a vacillare in seguito all’internamento in Germania. Dopo aver soggiornato nei manicomi di San Servolo e Mogliano Veneto, Rossi finisce definitivamente al Sant’Artemio nel ’33: le visite e gli stimoli di amici fra i quali lo scrittore Giovanni Comisso e lo scultore Toni Benetton non bastano a sottrarlo a un destino crudele. Il pittore, giorno dopo giorno, precipita inesorabilmente nella follia e trascorre intere giornate vagando per il manicomio con un fascio di carte variopinte sottobraccio; il 16 dicembre del 1947 si spegne vittima di un collasso circolatorio. Di lui resta una targa, collocata vicino alla terrazza nella quale l’artista amava trascorre molte ore nel perenne, vano inseguimento di indecifrabili chimere.
Le storie da raccontare sul Sant’Artemio sarebbero ancora molte: dal tentativo del direttore Tronconi di offrire rifugio ad alcuni perseguitati dal nazifascismo, al rastrellamento di quattro ebrei ricordati dalle pietre d’inciampo posate nel sedime dell’ex ospedale psichiatrico; dall’internamento di alcune protagoniste della Resistenza, alle numerose e sempre toccanti testimonianze di chi, al Sant’Artemio, ha sofferto, lavorato, sperato, delirato, sognato respirando “la quiete inesprimibile di un luogo di solitudine e tristezza“.
Con queste suggestioni ci avviamo al cancello principale. Qui immaginiamo una scena avvenuta chissà quante volte: nella penombra, le mani callose di una contadina passano furtivamente un fagotto a un ammalato. Dentro ci sono una bottiglia di vino e un pacchetto di sigarette. Nemmeno il tempo di uno sguardo e l’uomo si dilegua nel parco del manicomio con la rapidità di una faina; alla donna rimane soltanto l’amara consapevolezza di non avere strumenti per opporsi al doloroso mistero della pazzia.
Ci sarebbero voluti ancora molti anni prima che quel cancello venisse definitivamente aperto da uno psichiatra, Franco Basaglia, convinto che una società, per dirsi civile, debba dimostrare di saper accettare tanto la ragione quanto la follia.
(Autore: Marcello Marzani)
(Foto e video: Archivio Qdpnews.it)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata