In che modo e in che misura le due varianti del dialetto trevigiano di Sinistra e Destra Piave si differenziano nel lessico legato al corpo umano? Se lo è domandato nella sua tesi di laurea Cristina Facchin, 21 anni, di Cappella Maggiore, che ha concluso nei giorni scorsi il percorso triennale in Comunicazione Interlinguistica Applicata alla SSLMIT dell’Università di Trieste (ex Scuola interpreti e traduttori).
Classe 2003, la giovane – che nel corso dei tre anni ha studiato inglese, spagnolo e olandese – ha condotto la sua ricerca finale intorno al tema “Il corpo umano nel dialetto trevigiano: uno sguardo sul Piave”, approfondendo somiglianze e differenze tra le sponde sinistra e destra del fiume sacro alla Patria.
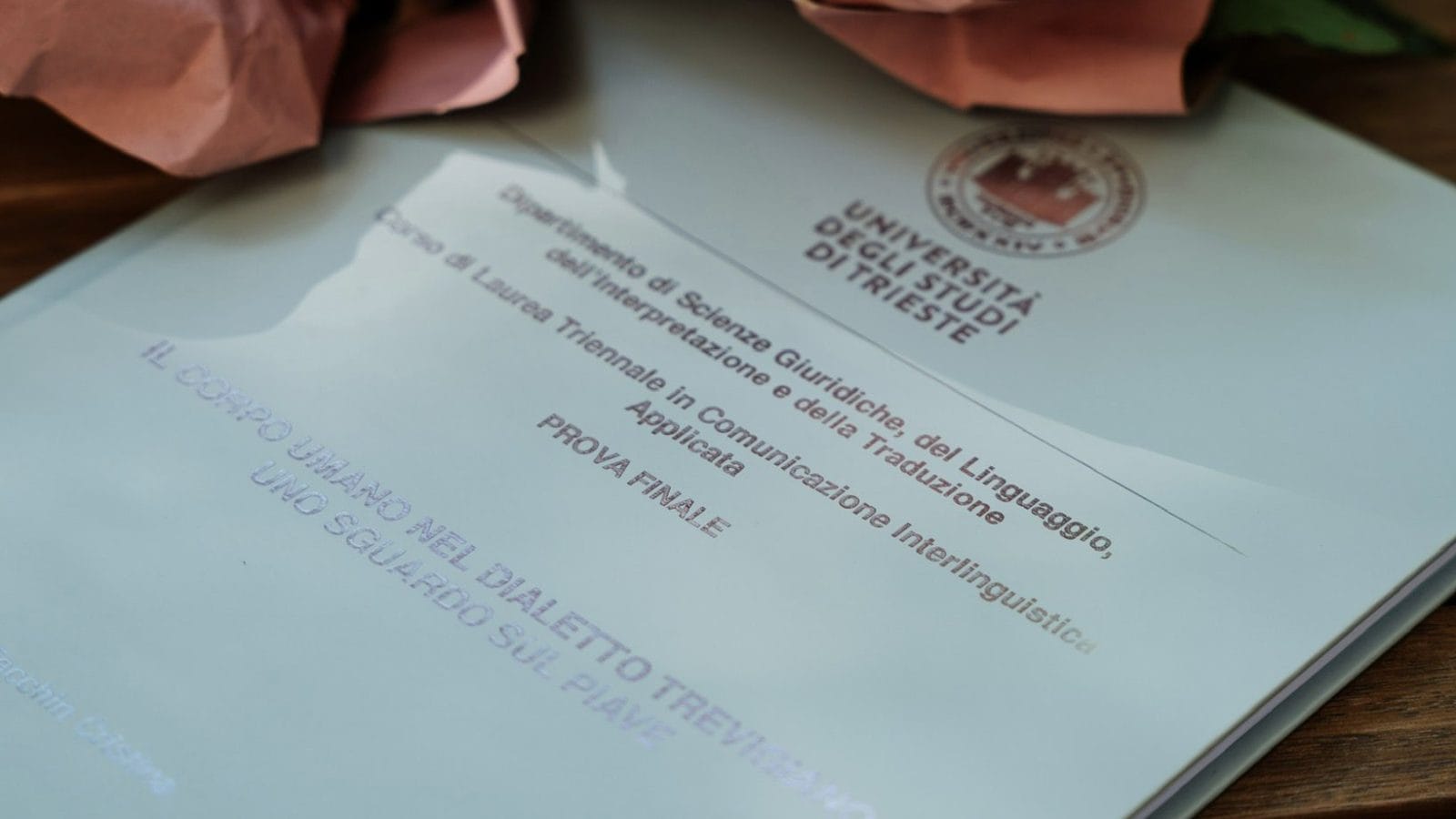
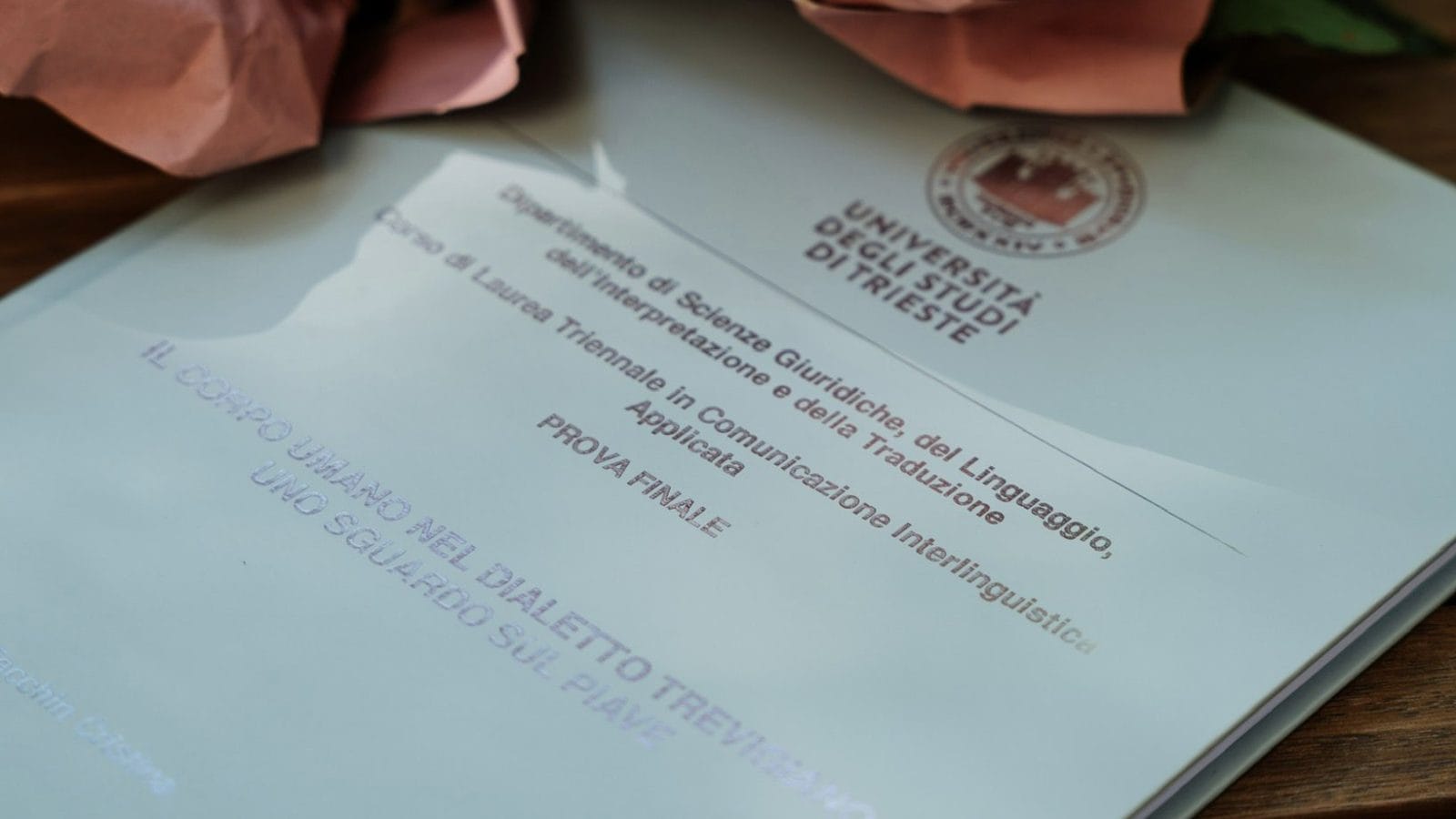
“Una barriera naturale – puntualizza Cristina – spesso costituisce anche una barriera linguistica: in molti casi i fiumi rappresentano anche dei veri e propri confini e dividono un territorio e la sua popolazione. È chiaro che, anche se non più così fortemente ai giorni nostri, un fiume può essere una grande divisione di un territorio, portando anche a una differenza nell’aspetto linguistico”.
Ma quindi, come è possibile indovinare se una persona è di Sinistra o Destra Piave dal modo in cui parla? “Dalla cantilena si può identificare la provenienza di una persona – dice la neolaureata – ma ovviamente non è una regola. Invece, ci sono moltissime somiglianze, soprattutto per quelle parti del corpo visibili e più ‘comuni’ come occhi, mani e braccia: se esistono delle differenze tra i parlanti sono così piccole che non vengono neanche considerate. In generale, le differenze si riscontrano nel modo di rendere la parola dalla stessa radice: in Sinistra Piave si tende a usare la ‘z’ e tagliare le vocali finali, mentre in Destra Piave a mantenere le vocali usando una ‘s’”. Ne è un esempio la variante di braccio: in Sinistra Piave, brazh, mentre in Destra brasso.
Per la sua ricerca, Cristina ha unito alla consultazione bibliografica i dati orali raccolti con delle interviste a venti uomini e donne del territorio, dell’età compresa tra i 50 e i 65, dieci per sponda: “Rispecchiano il dialetto di oggi – spiega Cristina – e mostrano un’influenza dell’italiano non così ampia come nei giovani, ma abbastanza presente da poterla identificare rispetto al dialetto più ‘tradizionale’”.
“Questa fascia di età – prosegue – è stata scelta a priori per poter avere un quadro attuale dei parlanti di questo dialetto: invece, i giovani non sempre lo parlano, oppure hanno grandi influenze dell’italiano, mentre la testimonianza di un dialetto più antico dell’elaborato arriva dall’atlante linguistico stesso”.


Un lavoro che ha portato Cristina – dal 2017 nel coro giovanile SingOverSound di Vittorio Veneto – ad avere contatto diretto con persone di ogni parte della Marca, in cui il tema della valorizzazione del dialetto è molto sentito.
“Essendo uno studio basato sul corpo umano – racconta la giovane – alcune delle parole che costituivano la ricerca sono poco utilizzate: penso ad esempio a ‘lentiggini’ o ‘articolazioni’. Molti intervistati erano un po’ confusi o comunque divertiti dal fatto che non sapevano come rendere in dialetto alcune delle voci dell’intervista. Posso dire però che erano tutti molto interessati alla mia tesi di laurea e contenti di fare parte di questo studio”.
Le difficoltà riscontrate nel tradurre termini specifici non hanno però oscurato in Cristina una importante consapevolezza: il dialetto, pur cambiando, continua a far parte della quotidianità: “Io credo che sia ancora vivo – commenta – si è certamente evoluto e molte parole che ora usiamo nel dialetto sono in realtà italiane ma ‘dialettizzate‘ nella forma: si sta però adattando ai tempi odierni. Ci sono ovviamente persone che lo parlano di più e altre che lo conoscono meno, ma in linea generale, e da quello che ho potuto constatare nelle interviste, è ancora presente nelle nostre vite di tutti i giorni”.
E infine Cristina – che ha deciso al momento di non proseguire gli studi – rivolge uno sguardo oltre la ricerca accademica con considerazioni legate al forte senso di appartenenza alla Marca trevigiana: “Studiare i dialetti è un modo per valorizzare una delle componenti del nostro territorio, fa parte della nostra cultura tanto quanto il cibo tipico o la nostra storia – conclude -. Non so come si evolverà il nostro dialetto in futuro ma spero che continui ad essere parte della nostra quotidianità e che non vada persa questa parte della nostra identità”.
(Autrice: Beatrice Zabotti)
(Foto: Alessandro Brino – per concessione di Cristina Facchin)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata









