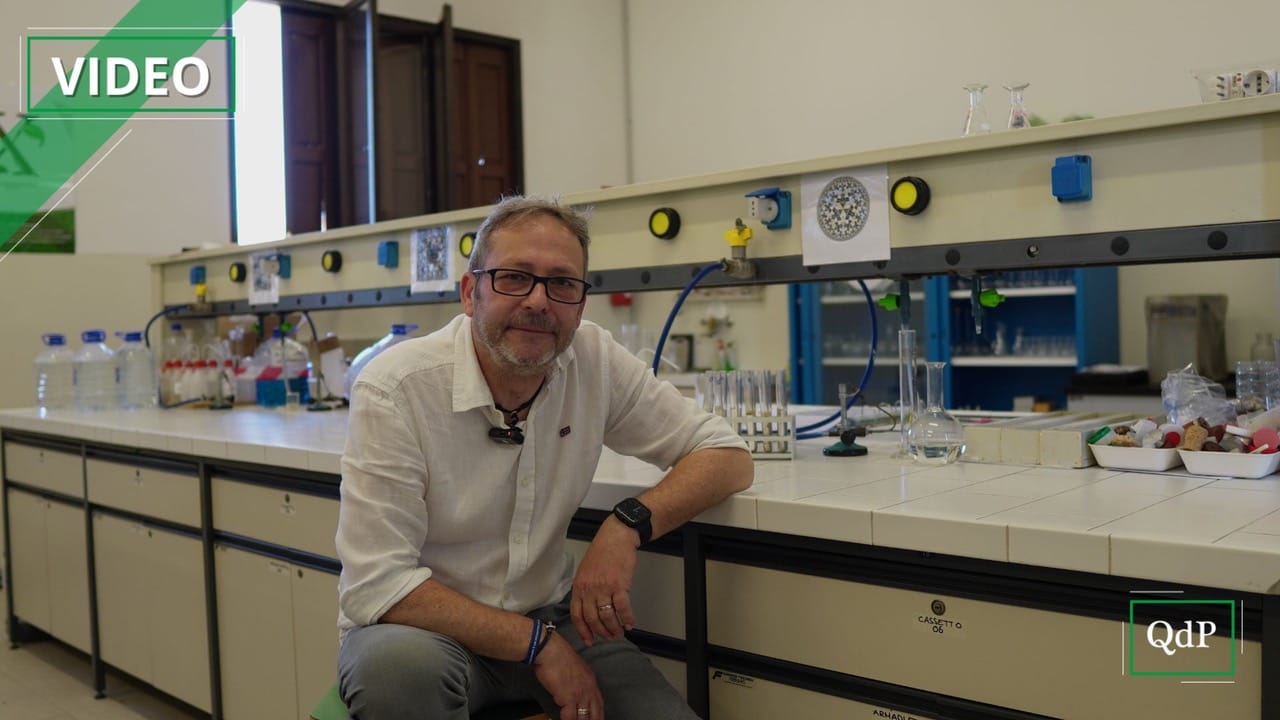La parola della lingua italiana “alibi” è ormai parte del nostro linguaggio quotidiano, spesso utilizzata nel senso figurato di giustificazione o scusa, ma originariamente legata al linguaggio del diritto penale. La sua etimologia, però, rivela un significato più profondo e affascinante, radicato nel latino e nella filosofia del “trovarsi altrove”.
Sono molto interessanti l’origine del termine e il suo sviluppo semantico, partendo dalla scomposizione delle due radici latine che lo compongono: alius e ibi.
L’etimologia di alibi affonda le sue radici nel latino classico, dove è composto da due elementi: Alius: “altro” o “in un altro luogo”, che indica una differenza o una separazione spaziale, e Ibi: “lì”, “là”, o “ivi”, un avverbio di luogo che denota una posizione definita.
La combinazione di questi due termini (alius + ibi) dà origine alla parola, il cui significato letterale è “altrove da lì” o “in un altro luogo”. Questo senso originario riflette un concetto spaziale: essere in un luogo diverso rispetto a quello di riferimento. La parola si configura, quindi, come un’espressione che indica la posizione fisica di una persona o di un oggetto, distinto da un luogo specifico.
Nella tradizione giuridica latina, la parola assume un significato tecnico, entrando a far parte del vocabolario legale. Un alibi è una dimostrazione che un accusato non poteva trovarsi sulla scena del crimine poiché, al momento dell’evento, era “altrove”. Questa nozione di “essere in un altro luogo” diventa fondamentale per stabilire l’innocenza in un processo.
Come afferma Patrizio Lo Votrico nel suo “Libreriamo is culthic”, ”il termine si è mantenuto intatto nelle lingue europee moderne, inclusa l’italiana, dove ha mantenuto il suo senso originario nel contesto giudiziario. In altre parole, l’alibi è una prova che sposta fisicamente il soggetto da un luogo a un altro, offrendo una giustificazione basata sulla realtà spaziale. Col tempo, il termine si è esteso dal linguaggio tecnico legale al linguaggio comune, acquisendo sfumature più figurative. Nel linguaggio corrente, un alibi non è più necessariamente una prova legata a un luogo, ma può indicare una giustificazione o una scusa”. Ad esempio, si può parlare di “avere un alibi” per giustificare un comportamento, un errore o una mancanza. Questa evoluzione semantica è tipica di molte parole di origine latina, che, attraversando i secoli, hanno ampliato il loro campo d’uso. Tuttavia, il concetto di separazione – fisica o metaforica – dal luogo o dalla responsabilità originale resta al centro del significato della parola.
Anche nel linguaggio quotidiano, l’uso di questo termine ha assunto una sfumatura più leggera e ironica. Dire “non ho un alibi” può essere usato per ammettere una colpa minore o per scherzare su una situazione in cui si cerca una scusa per giustificarsi. La parola ci mostra come il linguaggio possa evolversi mantenendo intatte le sue radici. Da un’espressione tecnica del diritto romano a un termine comune del linguaggio contemporaneo, questa parola ha attraversato secoli e culture senza perdere il suo nucleo semantico: la separazione, l’essere “altrove”.
L’etimologia di “alibi” ci ricorda anche il potere delle parole latine di influenzare il nostro modo di pensare e comunicare. Ancor oggi, in un tempo e in una fisicità di luoghi in cui siamo spesso “altrove” con il pensiero e con l’animo, il termine ci invita a riflettere sulla nostra presenza e sulle nostre responsabilità, che siano legali, morali o semplicemente personali. Infatti, siamo spesso “altrove” in linea con la parola latina “alibi”, perché spesso latitiamo, disertiamo, veniamo meno a quello che dovrebbero essere le chiamate di responsabilità, le richieste di presenza, gli appelli a partecipare per essere di aiuto e per coltivare il bene, specie laddove ci possano essere persone in difficoltà. Coltiviamo spesso alibi, scuse, ci chiamiamo fuori, siamo lontani e assenti, soprattutto quando vengono alla luce occasioni in cui sarebbe saggio e importante invece “rimanere dentro” i processi, essere protagonisti delle situazioni, contribuire a portare le proprie competenze e le proprie qualità umane nell’ambito delle cose e degli eventi che richiedono soluzioni, presenti, attuali, efficaci. Qui, non altrove.
Eppure ci sfiliamo spesso, siamo sempre da altre parti, con il cuore e con la mente, preoccupati soltanto di noi stessi e delle nostre comodità, senza la volontà di “lasciarsi disturbare dal prossimo”, come se la felicità dipendesse da solitudini, egoismi, ambizioni e traguardi a tutti i costi, e non invece dalla ricchezza delle relazioni, dalla capacità di presenza, dalla prossimità verso chi ha bisogno, dalla disponibilità al dialogo e alla risposta, dalla luce e dal sapore di un’esistenza vissuta nella pienezza di gesti e di significati. Qui ed ora, non altrove, senza alibi.
(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata