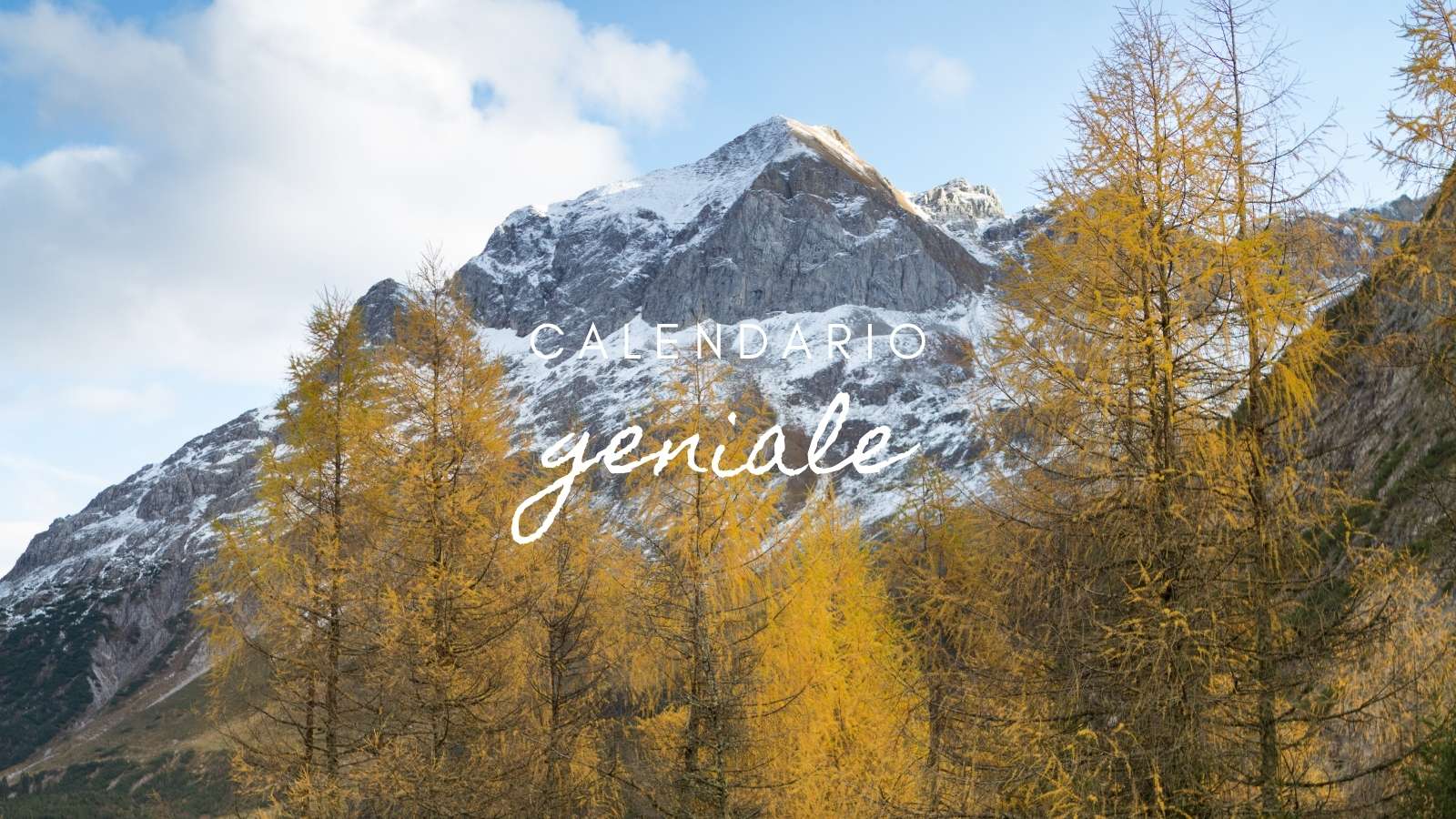Il nostro rapporto con le api affonda le radici nella preistoria. Le pitture rupestri delle Cuevas de la Araña in Spagna, risalenti a 7000 anni fa, testimoniano già la nostra antica relazione con questi insetti, mostrandoci una figura umana sospesa su liane mentre raccoglie favi da un anfratto nella roccia. Per millenni, l’umanità ha utilizzato il miele come uno dei pochi dolcificanti naturali disponibili e la cera d’api per numerosi scopi pratici, ma la nostra comprensione di questi straordinari insetti è rimasta a lungo superficiale.
Quando oggi parliamo comunemente di “api”, nella mente di molti appare l’immagine di un alveare geometrico, popolato da operose creature che producono miele. Ma questa è solo una piccola parte di un mondo vastissimo. L’Apis mellifera, l’ape domestica europea, è soltanto una delle 27 specie del genere Apis, di cui unicamente due sono state addomesticate. Come pecore, capre e altri animali domestici, l’ape mellifera ha seguito l’uomo nelle sue migrazioni, diffondendosi in quasi tutto il pianeta. È un animale allevato, non molto diverso dai polli o dai bovini che popolano le nostre fattorie.
Il panorama degli impollinatori, però, è incredibilmente più ampio e diversificato. Nel mondo esistono circa 20.000 specie di api, di cui ben 16.000 svolgono un fondamentale ruolo di impollinazione. Solo in Italia, ne possiamo contare circa 1.000 specie selvatiche, ciascuna con caratteristiche uniche, abitudini specifiche e preferenze di fiori differenti. E le api sono solo una parte degli impollinatori: farfalle, falene, coleotteri, vespe, mosche, alcuni uccelli, pipistrelli e persino piccoli mammiferi contribuiscono a questo processo vitale per gli ecosistemi.
La società delle api domestiche è stata studiata con particolare attenzione. Aristotele fu il primo a chiedersi se dietro l’apparente caos di una colonia potesse nascondersi un comportamento intelligente. L’etologia moderna definisce l’eusocialità come il livello più elevato di organizzazione sociale, con la cooperazione nelle cure parentali, la convivenza di generazioni diverse e la divisione in caste. Karl von Frisch, premio Nobel nel 1973, scoprì le sofisticate “danze” con cui le api comunicano la posizione dei fiori, rivelando la loro capacità di percepire raggi ultravioletti, luce polarizzata e di possedere una sorta di orologio interno.
Ma confondere la crisi degli impollinatori con i problemi dell’apicoltura è un errore concettuale dalle gravi conseguenze. Quando gli scienziati lanciano l’allarme sulla drammatica diminuzione degli impollinatori, si riferiscono principalmente alle specie selvatiche, non alle api domestiche. È come se, preoccupati per la scomparsa dei lupi, ci concentrassimo esclusivamente sui problemi sanitari dei cani domestici.
Le api selvatiche e gli altri impollinatori sono fondamentali per il mantenimento degli ecosistemi. Il 90% delle piante selvatiche da fiore dipende da loro per la riproduzione, e il 75% delle nostre colture alimentari beneficia della loro azione in termini di produzione e qualità. Mentre l’ape domestica visita preferibilmente fiori ricchi di nettare e facilmente accessibili, molte specie selvatiche si sono co-evolute con piante specifiche, sviluppando adattamenti reciproci straordinari: alcune api possono visitare solo determinati tipi di fiori, e alcuni fiori possono essere impollinati solo da specifiche specie di insetti.
Le api selvatiche non vivono in alveari artificiali e non producono miele per noi. Molte sono api solitarie, che nidificano nel terreno, in cavità naturali o in piccoli tunnel scavati nel legno. Non hanno apicoltori che si prendono cura di loro. Se una popolazione di api selvatiche scompare da un territorio, non c’è nessuno a reintrodurla artificialmente. La loro sopravvivenza dipende esclusivamente dalla disponibilità di habitat idonei e dalla presenza di risorse alimentari sufficienti.
Gli apicoltori europei, con i loro 17 milioni di alveari, possono rispondere alle perdite di api domestiche producendo nuove colonie. È un’attività economica, un’industria che può compensare le perdite. Le api mellifere non si estingueranno finché esisteranno persone interessate a coltivarle. Al contrario, la diminuzione delle api selvatiche rappresenta una vera emergenza ecologica, un segnale di allarme per la biodiversità globale.
Certamente, anche le api domestiche affrontano minacce significative: l’acaro Varroa destructor, l’Ape africanizzata (un ibrido problematico), i pesticidi usati in agricoltura. Ma è fondamentale comprendere che le soluzioni per proteggere le api domestiche potrebbero non essere sufficienti o adeguate per salvaguardare le specie selvatiche.
Il fenomeno definito “beewashing” – concentrare l’attenzione pubblica esclusivamente sulla crisi delle api mellifere – rischia di farci ignorare la silenziosa scomparsa di migliaia di altre specie di impollinatori egualmente, se non più, importanti per l’equilibrio degli ecosistemi. È come guardare solo alla punta di un iceberg, ignorando la massa sommersa che rappresenta la vera entità del problema.
Per proteggere realmente gli impollinatori, dobbiamo adottare un approccio che consideri l’intero spettro della biodiversità. Questo significa preservare habitat naturali diversificati, ridurre l’uso dei pesticidi, favorire l’agricoltura biologica e promuovere la presenza di aree fiorite anche in contesti urbani. Significa comprendere che un alveare di api domestiche nel giardino non sostituisce la ricchezza di un prato fiorito selvatico popolato da decine di specie diverse di impollinatori.
La prossima volta che osserviamo un’ape mellifera intenta a raccogliere nettare, dovremmo ricordarci che è solo una delle migliaia di operaie instancabili che mantengono in vita la biodiversità del nostro pianeta. E che mentre l’alveare domestico è sotto la protezione umana, i suoi cugini selvatici sono sempre più minacciati da un mondo che cambia troppo velocemente perché possano adattarsi. La vera sfida è proteggere tutti gli impollinatori, non solo quelli che ci forniscono miele.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata