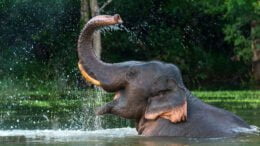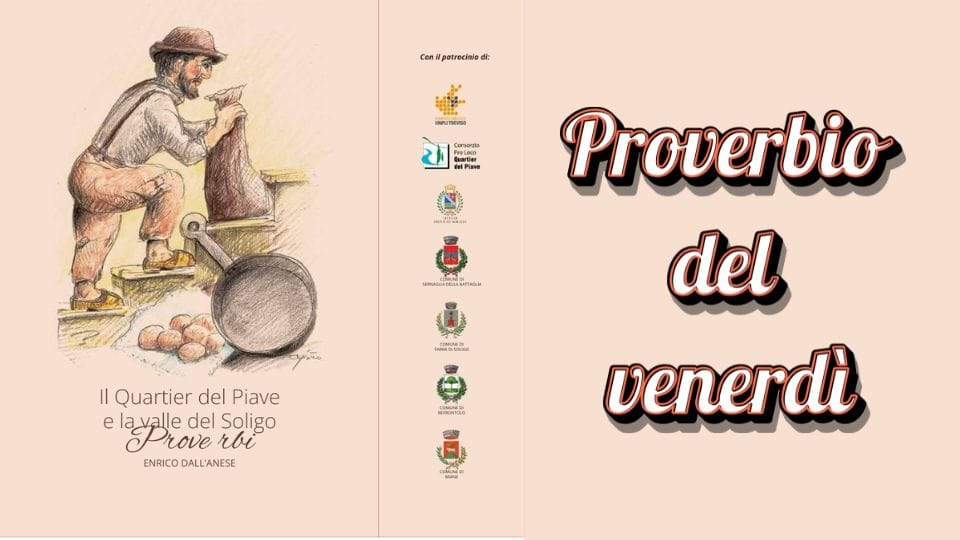In questa giornata internazionale del Mediterraneo, voglio raccontare la storia del mammifero marino più raro e affascinante del nostro pianeta. Tra le acque cristalline che bagnano le coste italiane e le isole più remote, si nasconde uno dei tesori più preziosi della biodiversità marina: la foca monaca del Mediterraneo, conosciuta scientificamente come Monachus monachus. Questo straordinario pinnipede rappresenta un testimone silenzioso di un ecosistema che ha attraversato millenni di storia e che oggi lotta per la sua sopravvivenza.
La storia di questo animale straordinario si intreccia intimamente con quella della laguna di Venezia, diventata negli ultimi anni un simbolo della possibile rinascita della specie. L’estate del 2013 rimarrà impressa nella memoria dei veneziani come quella di “Pryntyl”, il nome affettuoso dato dalla comunità a un giovane esemplare che per settimane aveva fatto capolino tra i canali della Serenissima. Otto avvistamenti in tre settimane avevano catturato l’attenzione di esperti e cittadini, dal canale naturale Perarolo vicino a Poveglia fino alle acque di Bibione, dove un surfista aveva incontrato quello che sembrava essere un maschio adulto nuotando verso Venezia.
La famiglia Ferro di Chioggia aveva poi immortalato il momento decisivo: un video che mostrava la foca saltare tranquilla e beata in mezzo ai bagnanti, nei pressi dell’Isola Verde. Quel filmato, dopo accurate verifiche scientifiche, aveva confermato definitivamente la presenza della foca monaca in laguna, trasformando quello che molti consideravano una leggenda metropolitana in una realtà scientifica documentata. Gli esperti del Gruppo Foca Monaca avevano ipotizzato che Pryntyl fosse uno dei tre o quattro figli di una foca adulta che si era insediata nell’Istria meridionale, capace di percorrere le ottanta miglia che separano Veneto e Croazia in poche ore.
Questo fascino della laguna veneziana per la foca monaca non è stato un episodio isolato. Nel 2016, durante il periodo di Ferragosto, nuove segnalazioni avevano riacceso la speranza: un comandante di vaporetto ACTV aveva avvistato un esemplare durante il servizio tra Lido Treporti e Burano, osservando per pochi istanti il muso caratteristico emergere a pochi metri dalla fiancata del battello. Altri avvistamenti si erano susseguiti nelle stesse settimane, dal lato sud di San Nicolò alla bocca del Lido, confermando secondo i biologi marini che “la laguna di Venezia è un ambiente estremamente importante per la sopravvivenza dei giovani individui che provengono dalle vicine coste dalmate”.
Anche nel 2018, le acque tra Chioggia e il canale del Brenta avevano registrato nuovi avvistamenti. Questi eventi non erano casuali: rappresentavano la conferma di una presenza stabile di foche monache nelle vicine coste croate, da dove alcuni individui si spingevano periodicamente fino alle acque veneziane.
La foca monaca è una creatura dalle abitudini riservate e dai comportamenti complessi. Durante il giorno cerca rifugio nelle grotte marine, luoghi appartati dove può riposare indisturbata, mutare il pelo e, nei momenti più delicati della sua vita, partorire e allattare i piccoli. Questi ambienti rocciosi e protetti rappresentano vere e proprie nursery naturali, santuari dove si perpetua la specie. Le acque aperte del Mediterraneo diventano invece il suo territorio di caccia, dove si muove con eleganza alla ricerca di pesci e molluschi, dimostrando le straordinarie capacità natatorie che la rendono una perfetta abitante degli abissi.
Recenti studi condotti dall’Università di Milano-Bicocca hanno rivoluzionato la nostra comprensione della distribuzione di questa specie nel Mediterraneo. Grazie a innovative tecniche di DNA ambientale, i ricercatori hanno potuto tracciare una mappa aggiornata della presenza della foca monaca, individuando sei aree cruciali dove questi animali trovano ancora rifugio. Dall’Alto Adriatico, tra l’Istria e la laguna di Venezia, fino alle coste del Salento e al Golfo di Taranto, dalle isole minori siciliane alla Sardegna orientale con il suggestivo Canyon di Caprera, dall’Arcipelago Toscano alle lontane Baleari, si disegna una geografia della speranza per questa specie minacciata.
Il progetto “Spot the Monk”, coordinato dal gruppo di DNA ambientale marino dell’ateneo milanese, ha rappresentato una svolta metodologica nel monitoraggio della fauna marina. Analizzando campioni di acqua di mare prelevati in 120 punti diversi del Mediterraneo centro-occidentale, gli scienziati sono riusciti a rilevare tracce molecolari della foca monaca anche in aree dove non si registravano avvistamenti diretti da decenni. Questo approccio non invasivo ha permesso di confermare la presenza di popolazioni nascoste e di ridefinire le strategie di conservazione.
Oltre agli episodi veneziani del passato, anche i mesi recenti hanno portato segnali incoraggianti per il ritorno della foca monaca nelle acque italiane. Il 25 aprile 2025 è stata avvistata a Punta Campanella nella omonima Area Marina Protetta. Il 1º e il 10 maggio 2025 è stata avvistata a Capri mentre cacciava e si nutriva sotto costa, mentre il 12 maggio 2025 a largo delle coste dell’isola d’Ischia in località Sant’Angelo, è stata avvistato un esemplare di foca monaca intento a mangiare una murena di grosse dimensioni. Questi avvistamenti nel Golfo di Napoli rappresentano un segnale positivo di un possibile graduale ritorno della specie in aree che un tempo frequentava abitualmente.
La rarità della foca monaca del Mediterraneo la rende uno degli animali più preziosi del nostro mare. Ogni incontro con questi magnifici mammiferi marini rappresenta un evento straordinario che richiede rispetto e consapevolezza. Quando ci si trova di fronte a una foca monaca, sia essa adagiata su una spiaggia rocciosa o intenta a nuotare nelle acque blu, è fondamentale ricordare che stiamo osservando un essere vivente estremamente vulnerabile al disturbo umano.
La vicinanza dell’uomo può rappresentare una fonte di stress incredibile per questi animali. Una foca che riposa su uno scoglio ha scelto quel luogo per motivi precisi: sicurezza, tranquillità, temperatura ideale. L’avvicinarsi di persone curiose, il rumore di voci o di imbarcazioni, la presenza di animali domestici possono scatenare una reazione di fuga che interrompe cicli vitali fondamentali. Particolarmente delicata è la situazione quando si tratta di femmine con cuccioli: lo stress causato dalla presenza umana può portare all’abbandono del piccolo, compromettendone definitivamente la sopravvivenza.
Le regole per un incontro rispettoso con la foca monaca sono semplici ma tassative. Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno cinquanta metri, muoversi lentamente e senza rumori bruschi, spegnere i motori delle imbarcazioni e attendere che l’animale continui il suo percorso naturale. In acqua, se si ha la fortuna di incontrare una foca durante una nuotata o un’immersione, il comportamento corretto è quello di allontanarsi gradualmente, permettendo all’animale di mantenere il controllo della situazione.
La protezione legale di cui gode la foca monaca non è solo una questione burocratica, ma rappresenta il riconoscimento del valore inestimabile di questa specie per l’equilibrio dell’ecosistema marino mediterraneo. Ogni esemplare che sopravvive e si riproduce contribuisce a mantenere viva una linea evolutiva che risale a milioni di anni fa e che oggi è ridotta a poche centinaia di individui in tutto il Mediterraneo.
L’educazione e la sensibilizzazione del pubblico rappresentano strumenti fondamentali per la conservazione della foca monaca. Ogni pescatore, ogni subacqueo, ogni turista che visita le coste mediterranee può diventare un alleato nella protezione di questa specie. Segnalare gli avvistamenti alle autorità competenti, come la Capitaneria di Porto, fornisce dati preziosi per monitorare i movimenti e le abitudini degli animali, contribuendo agli sforzi di ricerca e conservazione.
Il futuro della foca monaca del Mediterraneo dipende dalla nostra capacità di coesistere rispettosamente con questa specie straordinaria. Ogni gesto di attenzione, ogni comportamento responsabile, ogni momento di silenzio mantenuto durante un incontro fortuito contribuisce a scrivere un capitolo di speranza nella storia di conservazione di uno dei mammiferi marini più rari del pianeta. In questo mare che ci unisce tutti, la foca monaca rappresenta un simbolo di resilienza e di bellezza che merita di essere preservato per le generazioni future.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata