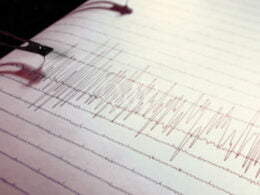Nel dicembre del 2011, mentre milioni di informazioni digitali attraversavano l’Europa in frazioni di secondo attraverso cavi di fibra ottica, un giovane lupo compiva un viaggio molto più lento ma infinitamente più significativo. Slavc, un maschio di quaranta chilogrammi originario delle Alpi Dinariche slovene, percorreva 1176 chilometri in cento giorni, attraversando Slovenia, Austria e Italia settentrionale. Un radiocollare GPS documentava ogni suo passo in un’odissea biologica che avrebbe implementato la mappa della ricolonizzazione europea.
Quella di Slavc non è però solo la cronaca di un “biologicamente ordinario” spostamento geografico. È la storia di come un animale selvatico possa diventare, suo malgrado, il catalizzatore di passioni millenarie, il punto di convergenza di conflitti culturali ancestrali mai risolti, lo specchio in cui l’umanità contemporanea si ritrova a confrontarsi con i propri limiti nel comprendere e gestire la complessità della natura. Ed è proprio questa storia complessa, stratificata, che Paola Peresin racconta ne “Il Viaggio di Slavc – Errori, bugie, falsi miti e leggende sul lupo”, pubblicato da Kellermann Editore.
Fin dalle prime pagine, l’autrice dichiara con chiarezza le sue intenzioni: questo non sarà un “unboxing faunistico“, non sarà una di quelle promesse rassicuranti di sapere tutto sui lupi in quindici minuti né un contenuto facilmente digeribile da consumare tra uno scroll e l’altro sui social. In un’epoca in cui media digitali e intelligenze artificiali promettono risposte apparentemente sensate a qualsiasi domanda in pochi secondi, il libro di Peresin è invece una “miccia da accendere”, un invito alla fatica della comprensione autentica. Richiede il tempo disteso della lettura, la concentrazione esclusiva, la possibilità di fermarsi e sostare sui passaggi più complessi.
Il 6 marzo 2012, quando Slavc raggiunse l’altopiano della Lessinia in provincia di Verona, le Alpi orientali ritrovarono i loro lupi dopo più di un secolo di assenza. Ma quel territorio che le zampe di un predatore stavano esplorando per la prima volta dopo tanto tempo vibrava già di un’altra forma di movimento: quello delle informazioni digitali che trasformavano il lupo reale in infinite versioni virtuali di sé stesso, alcune eroiche, altre mostruose, tutte egualmente distanti dalla realtà di un animale che semplicemente cercava di vivere la sua vita. Mentre il radiocollare GPS trasmetteva le coordinate reali di Slavc nei pascoli della Lessinia, le sue coordinate virtuali attraversavano spazi completamente diversi: bacheche Facebook, gruppi WhatsApp, commenti online. In questi luoghi, Slavc si moltiplicava in narrazioni che avevano poco a che fare con la biologia e molto con proiezioni culturali profonde.
Peresin non si limita a documentare il viaggio geografico del lupo attraverso tre nazioni. Compie anche un viaggio a ritroso nel tempo, portando il lettore nelle steppe dell’Asia centrale di tremila anni fa, quando il lupo non era incarnazione del male ma guida spirituale, psicopompo capace di muoversi tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Dalle cerimonie sciamaniche con funghi allucinogeni ai Lupercalia romani, dalle figure divine come Hermes e Anubi al Lupo Celeste mongolo, l’autrice ricostruisce quella complessa rete di significati che per millenni ha legato l’umanità a questo predatore. Solo comprendendo questi strati di memoria collettiva si può capire perché un giovane maschio dinarico di quaranta chilogrammi sia diventato il catalizzatore di passioni che affondano le radici in concezioni millenarie della natura, della convivenza, del confine tra selvatico e domestico.
Il libro affronta con rigore scientifico ma linguaggio accessibile le dinamiche biologiche della dispersione, i pattern di movimento rivelati dai dati GPS, le strategie predatorie documentate sul campo. Ma non tradisce mai la complessità del fenomeno riducendolo a favola consolatoria o a emergenza da gestire con slogan immediati. Peresin mostra come il ritorno del lupo nelle Alpi orientali riveli l’inadeguatezza dei nostri sistemi concettuali: la scienza fatica a comunicare le sue scoperte, il diritto cerca di tradurre conoscenze biologiche in norme che bilancino tutela della specie e protezione delle attività umane, la burocrazia si perde in labirinti amministrativi che ignorano i tempi biologici creando emergenze permanenti.
L’autrice dedica particolare attenzione a un fenomeno preoccupante dell’epoca contemporanea: la proliferazione di contenuti digitali sulla fauna selvatica che confondono sistematicamente opinioni personali con dati empirici, esperienze aneddotiche con evidenze scientifiche. Questi sistemi, progettati per generare testo persuasivo e non per fornire risposte corrette, creano un universo comunicativo dove sequenze linguisticamente eleganti vengono scambiate per spiegazioni scientifiche. Contro questa deriva, il libro di Peresin rivendica la necessità di quella capacità abduttiva che solo il pensiero umano possiede: osservare fatti sorprendenti, formulare ipotesi causali alternative, selezionare spiegazioni credibili. Serve la fatica della ricerca, lo studio, la riflessione critica che danno senso ai dati.
Il 4 maggio 2012 furono scattate le prime immagini ufficiali di Slavc insieme alla femmina che aveva incontrato sull’altopiano della Lessinia. Una femmina di origine appenninica che, indipendentemente da lui, aveva raggiunto quelle montagne. Il 27 agosto dello stesso anno, il distacco programmato del radiocollare segnò la fine della trasmissione di dati geolocalizzati. Ma per lo Slavc digitale, l’avventura era appena iniziata. Le Alpi orientali avevano ritrovato i loro lupi dopo un secolo di assenza, ma l’umanità, di fronte a questo ritorno, sembrava aver perso qualcosa di altrettanto importante: la capacità di distinguere tra il lupo che cammina nei boschi e quello che corre nella rete digitale, tra la realtà con cui convivere e quella che si può solo immaginare.
“Il Viaggio di Slavc” non promette risposte facili. Offre invece la fatica necessaria per formulare domande più precise, per sviluppare strumenti interpretativi più adeguati, per immaginare forme di convivenza che rispettino tanto la complessità scientifica quanto la ricchezza culturale dei territori attraversati dal lupo. Come scrive Franca Zanichelli nella prefazione, discutere oggi di conservazione della natura è un problema molto complicato, e manca un’esperienza efficace trasmissibile. Abbiamo a disposizione tutti gli ingredienti immaginabili ma non riusciamo a cucinare piatti appetibili.
Il tempo che il lettore dedicherà a questo viaggio attraverso la storia biologica e culturale di Slavc sarà tempo sottratto alle certezze immediate dell’informazione istantanea, ma dedicato alla costruzione di una comprensione più profonda di cosa significhi abitare un mondo dove l’incontro tra specie diverse rimane sempre una questione aperta, sempre una sfida da accogliere con tutti gli strumenti che la conoscenza umana può offrire. Perché il viaggio di Slavc non racconta solo la ricolonizzazione delle Alpi orientali da parte di una specie selvatica. Documenta il tentativo della civiltà europea di elaborare nuove grammatiche della coesistenza in un’epoca in cui il confine tra naturale e artificiale, selvatico e domestico, controllo e autonomia si ridefinisce continuamente.
Un libro che accende fuochi invece di distribuire acqua fresca, una narrazione che invita i lettori a crescere insieme alla comprensione di dinamiche che dovrebbero esserci familiari ma che abbiamo dimenticato durante quel secolo in cui le Alpi orientali erano rimaste senza lupi. Slavc era tornato. Eravamo pronti? E oggi?
“Il viaggio di Slavc” è in libreria da oggi.
(Autore: Redazione Qdpnews.it)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata