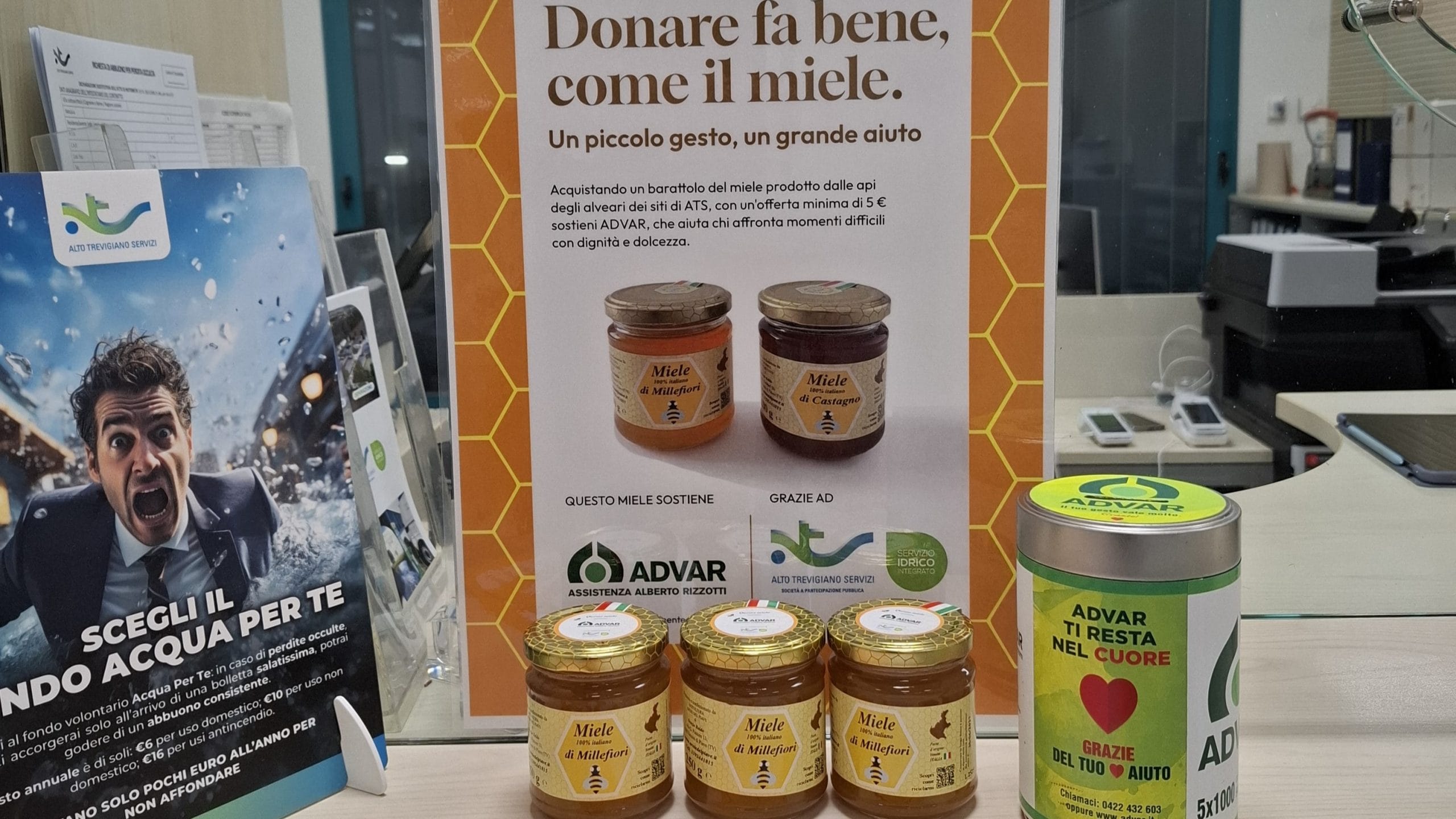Un auditorium gremito ha accolto Enrico Galiano, scrittore e insegnante, arrivato a Montebelluna per presentare il suo nuovo libro Quel posto che chiami casa. L’incontro, promosso dalla Libreria Zanetti insieme alla biblioteca comunale e inserito nel Patto per la lettura dell’area montebellunese, si è trasformato in un’occasione di confronto sul futuro dei giovani e sulla loro capacità – sempre più ardita – di continuare a sognare.
Presentato da Danilo Zanetti, Galiano ha instaurato fin da subito un rapporto diretto e informale con il pubblico, mostrando quella naturale capacità comunicativa che lo ha reso uno degli insegnanti più seguiti anche online. Nato a Pordenone nel 1977, si è affermato con numerosi romanzi di successo senza trascurare la dimensione social: la sua webserie Cose da prof ha superato venti milioni di visualizzazioni su Facebook. A guidare il suo lavoro di insegnante è una visione pedagogica chiara, condensata in una frase emblematica: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».


In controtendenza rispetto ai canonici eventi di questo genere, il professore ha subito chiarito che non avrebbe presentato il suo libro in modo tradizionale: «Non lo farò perché mi imbarazzo, mi vergogno quasi, perché mi sembra di vendervi qualcosa…». Ha preferito invece utilizzare la sua nuova opera come spunto per analizzare le criticità di alcuni temi universali.
Il primo, provocatorio, è arrivato subito sotto forma di domanda al pubblico: «Ma voi ce l’avete ancora un sogno nella vostra vita? Chi lo ha, alzi la mano!». Un quesito che Galiano pone regolarmente anche ai suoi studenti. «Quando lo faccio, accade un fenomeno che andrebbe studiato: alle scuole medie si alzano circa il 90% delle mani» – ha raccontato, descrivendo l’entusiasmo dei ragazzi che vogliono ancora fare “l’astronauta” o “cambiare il mondo”.
La situazione cambia però radicalmente alle scuole superiori. «In certe scuole si arriva al 30% di mani alzate… mai oltre la metà». Nel descrivere il deserto di mani abbassate e sguardi spenti, Galiano si è chiesto cosa accada in quel breve lasso di tempo che separa la spensieratezza delle medie dal presunto “realismo” delle superiori. La risposta di una studentessa lo ha colpito profondamente: «È normale prof, diventi più grande, diventi più realista». A soli 16 anni, molti ragazzi smettono di sognare, considerandolo un lusso da abbandonare in favore della concretezza. Ancora più dura la reazione di un altro ragazzo, che lancia una vera e propria accusa verso il corpo docente: «Siete voi che ci fate passare la voglia di sognare». Una frase forte, che ha spinto il docente a interrogarsi su questo malessere diffuso.
Quelle narrate al pubblico sono reazioni dure, testimonianze reali del fatto che molti adolescenti si sentono intrappolati in un sistema che li spinge a essere “la versione di te che il mondo si aspetta”, lontani dalla loro vera essenza.
Per articolare ulteriormente la prospettiva, Galiano ha raccontato la storia di un suo altro ex allievo, Marco, un giovane campione di nuoto che, nonostante il successo e il plauso del padre, odiava la competizione e l’irrespirabile coltre di aspettative che soffocava la sua quotidianità. «Io non ce la faccio più» – ha detto in lacrime al professore, confessando che la sua vera passione era il disegno, una disciplina in cui non eccelleva. Marco aveva rinunciato a seguire la sua voce interiore per non deludere le aspettative altrui.
«Anche qui in sala è pieno di Marchi», ha affermato provocatoriamente l’autore, svelando un dato sconcertante: una ricerca ha dimostrato che solo il 19% degli adulti nel mondo occidentale è felice del proprio lavoro e inizia la giornata con la convinzione di seguire la propria inclinazione. «L’altro 81% cosa fa? Posticipa la sveglia… non vede l’ora che arrivi il fine settimana».
Galiano si è definito un “travasatore”, con il sogno di spostare più persone possibile “dall’81 al 19”, ovvero di aiutarle a trovare quel “posto che chiami casa”, che è la felicità di fare ciò che si ama.
Per avviare questo cambiamento, il professore ha proposto tre punti. Il primo, mutuato dalla poesia di Khalil Gibran, recita: “I vostri figli non sono i vostri figli.”. Una frase che può sembrare un’aporia, ma che nasconde un significato profondo. “Essi non provengono da voi ma attraverso di voi,” ha spiegato l’autore, sottolineando che i figli non sono una proprietà, ma individui ai quali gli adulti devono lasciare lo spazio per sbagliare e crescere.
“Potete dar loro tutto il vostro amore ma non i vostri pensieri. Potete sforzarvi di essere simili a loro ma non cercare di renderli simili a voi.”. L’autore ha sottolineato che l’orgoglio di un genitore non dovrebbe risiedere nella somiglianza del figlio, ma nella sua unicità e nel coraggio di contraddirli. “Sentitevi orgogliosi… perché voi siete gli archi dai quali i vostri figli come frecce viventi sono scoccati.” L’arco non decide la direzione della freccia, ma con la sua forza ne determina la velocità e la distanza. L’Arciere, con la “A” maiuscola, è un’entità superiore che guida il destino di ognuno.
Il secondo punto della riflessione ha visto la narrazione al pubblico di un episodio di vita scolastica in cui il professore ha chiesto ai suoi ragazzi di fare una lista delle accuse che rivolgerebbero a un adulto, e, una delle risposte più gettonate, è stata: la mancanza di coerenza. I ragazzi vedono i loro genitori o insegnanti non agire in base ai consigli che danno. Ad esempio, una studentessa ha scritto: “Mi dici sempre che devo essere me stessa, ma poi io ti vedo quando sei con le tue amiche, non ti riconosco neanche, diventi un’altra persona.” Un altro ragazzo ha criticato il padre, che gli consigliava di inseguire i suoi sogni, riscontrando però nello stesso tutto tranne “la faccia di uno che sta inseguendo il suo sogno.”.
Galiano ha messo in discussione il ruolo degli adulti, chiedendosi se non siano proprio loro i primi a non credere nei sogni, trasmettendo ai ragazzi il messaggio che non sono all’altezza di volare in alto. Spesso, gli studenti delle scuole professionali, ad esempio, sono lì perché gli è stato detto “devi volare basso,” una frase che, a detta di Galiano, “svilisce sia il ragazzo che la scuola intera”. Sono ragazzi a cui è stato insegnato che non meritano di sognare.
Tutti ricordano il secondo errore di Icaro, ovvero volare troppo vicino al sole. Galiano ha evidenziato il primo errore: volare troppo basso. “A volar troppo basso e si muore,” ha affermato, riferendosi a una “morte lenta” e silenziosa, descritta da Thoreau come “quieta disperazione.” È la vita di chi, per paura di fallire, non prova nemmeno a volare alto.


Il secondo errore di Icaro, invece, quello di volare troppo in alto, è spesso interpretato come un monito a restare entro i limiti. Ma Galiano ha ribaltato questa visione, sostenendo che se gli esseri umani si fossero sempre attenuti ai limiti, non avrebbero mai raggiunto la luna, scritto la Divina Commedia o concesso il voto alle donne. “La morale è un’altra”, ha spiegato. I sogni non si realizzano da subito ma sono il frutto di un percorso.
La sua provocazione è un faro che illumina la via d’uscita: spingere i ragazzi a non temere di volare alto, a inseguire la propria passione, anche se non eccellono, perché la vera realizzazione non è nel successo, ma nella felicità di fare ciò che si ama. Il compito degli adulti è quello di essere archi potenti, capaci di scoccare frecce verso orizzonti lontani, dando ai giovani la forza di non accontentarsi, di non tradire sé stessi trovando, finalmente, il “posto che chiami casa.”.
(Autore: Francesco Bruni)
(Foto: Francesco Bruni)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata