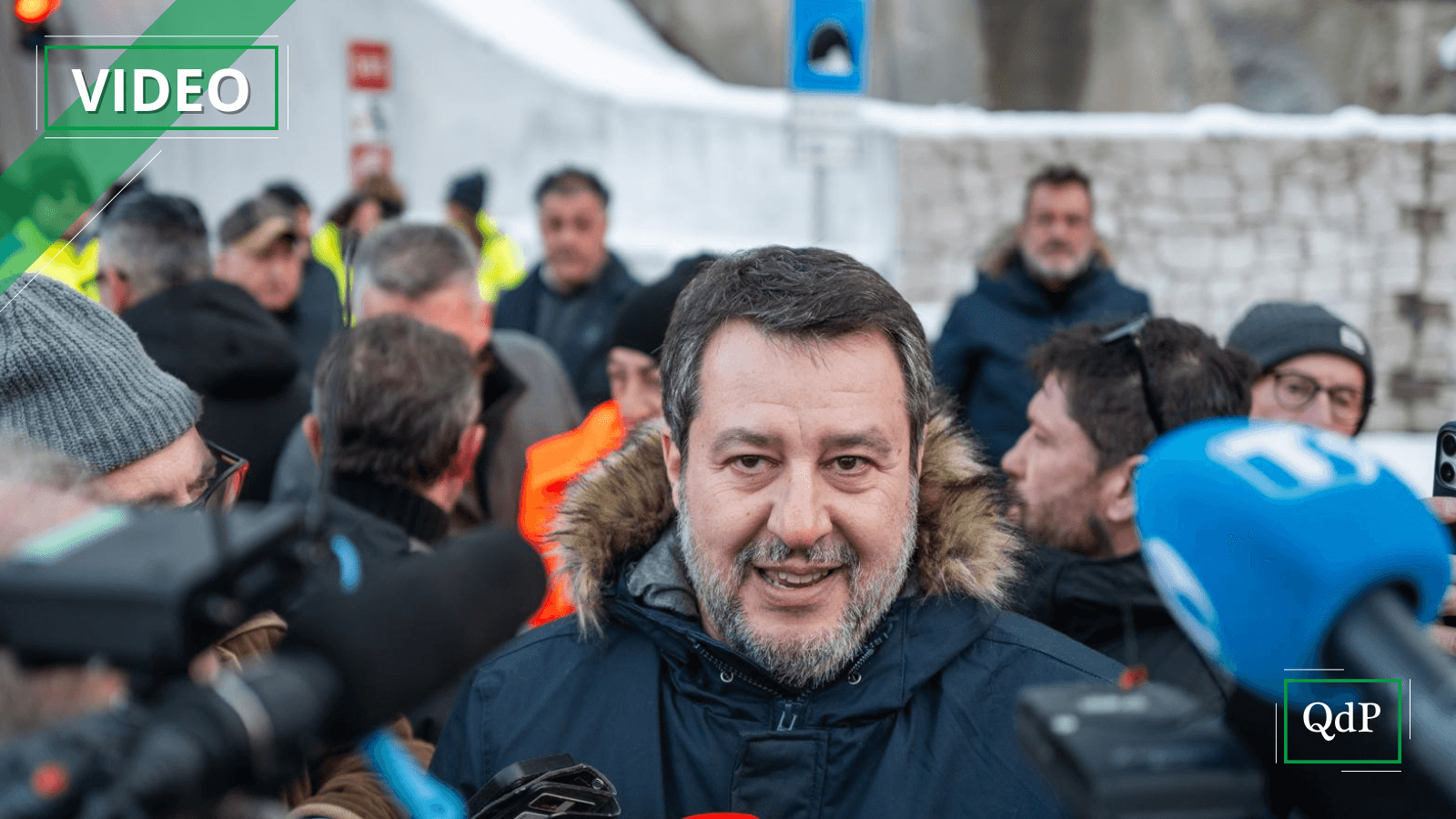Quando il povero Pinocchio si rese conto di esser stato ingannato dal Gatto e dalla Volpe, corse difilato a denunziare il furto degli zecchini d’oro che aveva ingenuamente sotterrato nel Campo dei Miracoli. Il giudice, dopo averlo ascoltato pazientemente, ordinò il suo arresto; i gendarmi “gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia”.
Metafora (ahimè sempre attuale) dell’ingiustizia terrena, la disavventura del povero burattino si conclude con la segregazione in gattabuia, sinonimo di carcere, prigione, galera: ma da dove deriva questo curioso termine che Carlo Collodi fu tra fra i primi a utilizzare per iscritto?
Alcuni propendono per associare la gattabuia con la gattaiola, l’apertura che oggi come un tempo consente ai gatti di entrare e uscire da abitazioni e cantine senza costringere i padroni di casa alla continua apertura e chiusura dei portoni. Diffusissima nel mondo anglosassone ove la si definisce cat door, cat flap o kitty door, la gattaiola nasce con lo scopo di arginare la proliferazione dei topi e di altri roditori nelle case. Si narra, ma non è affatto provato, che il celebre scienziato inglese Isacco Newton, padre della teoria sulla gravitazione universale, ne abbia addirittura ideato un modello con congegno a botola, per liberarsi dai ratti.
Oggi esistono gattaiole con sistemi a infrarosso, fotocellule, riconoscimento facciale e del microchip applicato al micio; un tempo ci si limitava a ricavare una porticina alla base degli usci di legno. Per chi volesse ammirare una straordinaria gattaiola è d’obbligo visitare la chiesa di San Giorgio a Montemerano, suggestivo borgo maremmano in provincia di Grosseto. Qui è custodita una pala quattrocentesca raffigurante la Vergine annunciata che un parroco ignoto pensò bene di riciclare come porta di fortuna: e poiché al buon uomo premeva difendersi dal freddo, ma anche dai topi, sull’opera d’arte fu ricavata un’apertura da cui il nome di “Madonna della Gattaiola”.
Una seconda teoria sulla genesi del termine gattabuia rimanda invece alla parola greca κατώγειον (sotterraneo) da cui le voci gergali sicule “catoja” o “catuio” nel senso di tugurio, stanza angusta e prigione.
E a proposito di prigioni non si possono non ricordare i famigerati Piombi di Venezia, teatro della rocambolesca fuga di Giacomo Casanova, libertino, letterato, alchimista e avventuriero di cui quest’anno si celebra il trecentesimo anniversario della nascita avvenuta nel capoluogo lagunare il 2 aprile 1725.
Realizzati nel Cinquecento e rimasti in funzione sino alla fine del Seicento, i Piombi presero il nome dal materiale di costruzione del sottotetto che amplificava il caldo d’estate, ma mitigava il freddo invernale. Ubicati a Palazzo Ducale, adibiti alla reclusione di uomini e occasionalmente donne, i Piombi erano peggiori delle Carceri Nuove, ma tutto sommato più “confortevoli” dei Pozzi, siti al piano terreno dell’edificio, dove i reclusi vivevano nella perenne semioscurità, sommersi dai miasmi e dall’umidità della laguna.
A rendere ulteriormente angosciante la reclusione nelle carceri della Serenissima contribuiva la frequente abitudine di lasciare i detenuti all’oscuro circa l’entità della pena e l’accusa che pendeva sul loro capo. Per contro, agli “ospiti” dei Piombi poteva essere concesso di arredare le celle con suppellettili di proprietà, ricevere cibo e piccole somme di denaro. Privilegi dei quali approfittò l’astuto Casanova che, grazie a un capiente vassoio ricolmo di maccheroni burro e parmigiano, riuscì a celare alla vista dell’aguzzino il provvidenziale punteruolo che gli consentì di evadere.
(Autore: Marcello Marzani)
(Foto: Lorena Morales da Getty Images)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata