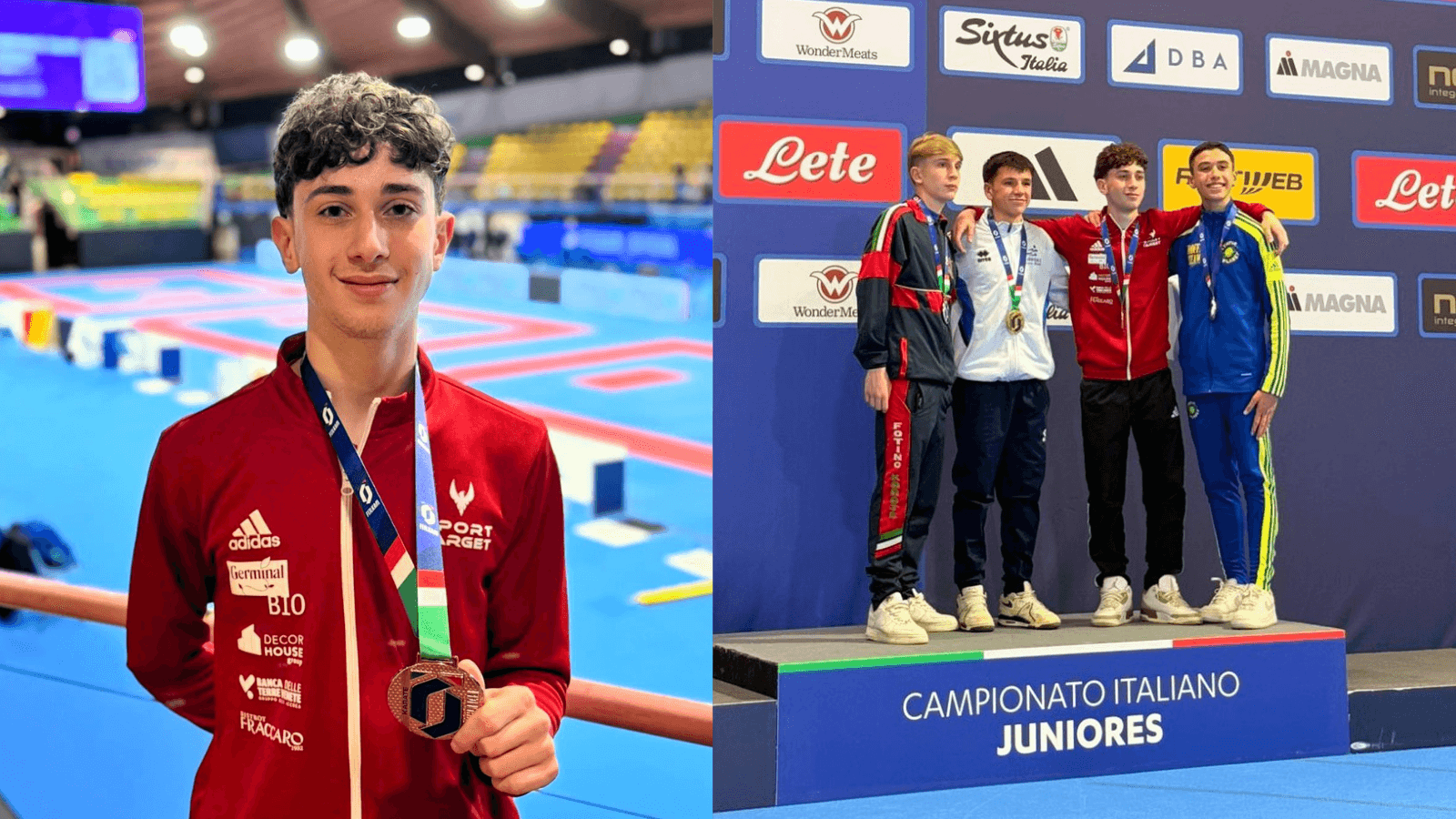“Noce e castagna, regali della montagna” recita un antico proverbio. Diffuso nella nostra penisola sin da epoche remote, il castagno era conosciuto dai Greci e dai Romani che apprezzavano le virtù nutritive e le proprietà salutari dei suoi frutti chiamati noci piatte, ghiande di Giove o noci nude. Un contributo decisivo alla diffusione del castagno lo diedero gli ordini monastici impegnati nella bonifica delle campagne abbandonate all’indomani delle invasioni barbariche: l’albero, oltre al frutto consumato fresco, essiccato o trasformato in farina, forniva legname per costruire e scaldarsi, tannino per la concia delle pelli, rami per i pali delle vigne, fronde e foglie per fare ceste, coprire i tetti delle malghe, imbottire rustici materassi.
A partire dal XIX secolo, complice una serie di fattori quali l’abbandono della montagna, l’avvento di nuovi materiali edili e la disastrosa diffusione di malattie come il mal dell’inchiostro, la castanicoltura ha vissuto una stagione di netto declino solo in parte attenuata dalla passione e dalla tenacia di pochi. Ed è grazie a loro se in Italia esistono ancora castagneti monumentali come quelli di Cuneo, del Monte Amiata e del Mugello in Toscana, di San Zeno nel veronese o di Vallerano a Viterbo.
Fra i prodotti tipici della Marca, come risulta dall’Atlante agroalimentare trevigiano, figurano i marroni di Combai e del Monfenera, località rinomate per la castanicoltura sin dal Medioevo. Si tratta del risultato di un’attenta opera di selezione i cui risultati sono frutti di eccezionale qualità, protagonisti di piatti umili o ricercati, dalla zuppa di marroni e chiodini ai mondoi (minestra di castagne secche), dalla bavarese di marroni con panna e vaniglia agli gnocchi di farina di castagne. Della medesima categoria delle tipicità alimentari trevigiane, fanno parte i mieli di castagno del Grappa e del Montello, scuri e aromatici.
Celebrati dagli antichi, cantati da poeti del calibro di Federico Garcìa Lorca a Pablo Neruda, i frutti della Castanea sativa si ritrovano spesso nel linguaggio comune, sotto forma di espressioni fra le quali “prendere in castagna”, ovvero sorprendere qualcuno mentre commette un’azione illecita, proibita o riprovevole. L’amministratore pubblico che accetta la bustarella, la coppia clandestina, il viaggiatore senza biglietto, sono tutti esempi in cui c’è il concreto rischio di essere colti in castagna.
Sulle origini della locuzione ci sono parecchi dubbi: pare che discenda dal latino marro o marronis, errore, o da vocaboli simili che in francese e spagnolo avrebbero a che fare con il commettere uno sbaglio, confondersi, ingannarsi, ma anche compiere una birbonata o un peccatuccio.
È il caso di coloro che fingono di passeggiare nel bosco per fare man bassa di marroni di proprietà altrui, sperando di non essere colti in castagna. I più scaltri, per evitare situazioni d’imbarazzo, mandano avanti anziani o bambini con l’intento di rabbonire il proprietario del bosco: un espediente nel quale, come insegna una favola di La Fontaine, i più deboli servono a cavar le castagne dal fuoco, ovvero ad assumersi per conto di altri il rischio dell’impresa; e se lo stratagemma non dovesse funzionare, per evitare una poderosa castagna (un pugno) da parte del derubato, si può provare a fare i finti tonti, parlando con difficoltà come se si avesse una castagna in bocca.
Se tutto ciò si rivelasse inutile, come suggerisce l’autrice di un aforisma che si cela sotto lo pseudonimo di egyzia, non resta che un’ultima strada: chiudersi a riccio!
(Autore: Marcello Marzani)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata