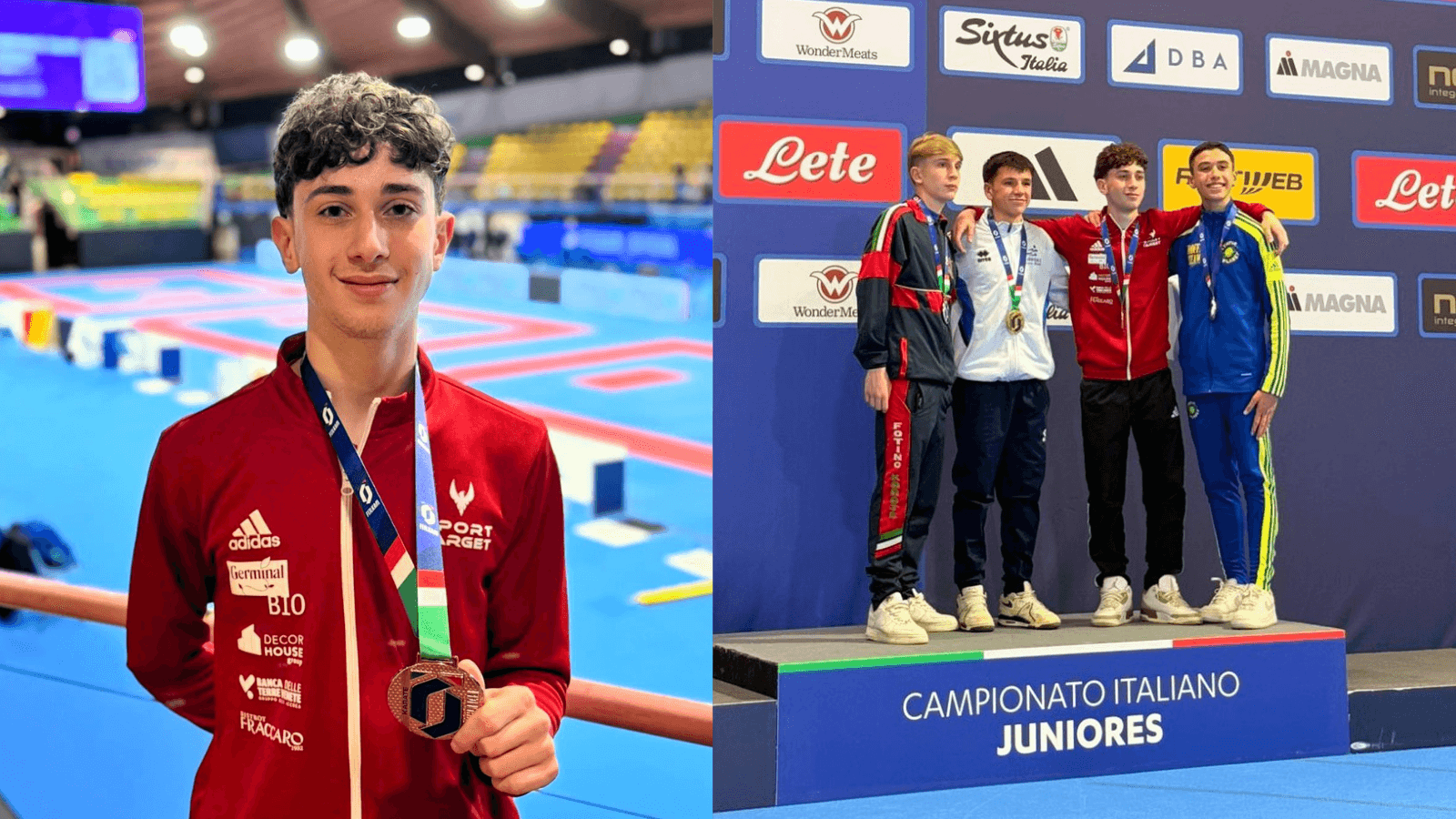Risorsa vitale gravemente minacciata dal cambiamento climatico, il ghiaccio riveste da sempre un ruolo di primo piano nella storia dell’uomo. Prezioso alleato capace di conservare a lungo gli alimenti più deperibili, prima dell’avvento dei moderni elettrodomestici, veniva accumulato nelle ghiacciaie o neviere ideate dai Sumeri quattromila anni fa e, fino a pochi decenni orsono, diffuse nelle nostre città e campagne.
In Veneto, a ridosso delle malghe montane, si costruivano le giazzere o giazere ove stipare la neve: scavate sotto il livello del suolo, con la porticina rivolta a settentrione, il tetto coperto di pietra o di foglie e ramoscelli (fojaròl), le neviere erano frigoriferi naturali nei quali riporre le vettovaglie più delicate. Se ne trovano ancora, oramai abbandonate, sul Monte Grappa e sui rilievi prealpini; nei dintorni di Trevignano, a una manciata di chilometri dalle sponde del Piave, è ancora visibile un’antica ghiacciaia profonda poco meno di dieci metri e larga cinque, testimonianza, assieme al forno a legna, dell’ingegno e dell’abilità dei nostri avi. A Venezia, la Calle del Giazzo evoca l’antica vendita del ghiaccio che, assieme al commercio dell’acquavite, era appannaggio dei caffettieri.
Sebbene prezioso, in certi contesti il ghiaccio rappresenta un ostacolo o addirittura un’insidia. Armati prima di utensili rudimentali e poi di attrezzature sempre più efficaci, gli uomini da sempre spezzano, trivellano o forano le lastre di ghiaccio per spostarsi, raggiungere l’acqua potabile, pescare. Nei paesi nordici, per avere la meglio sulla gelida morsa che attanaglia laghi, fiumi e mari, sono nate le imbarcazioni rompighiaccio la cui evoluzione è andata di pari passo con le esplorazioni artiche e antartiche, ed è proseguita con fini mercantili, militari, di soccorso e turistici.
Insomma, l’uomo si dedica da così tanto tempo a sbriciolare il ghiaccio che questa espressione ha finito col contagiare anche il linguaggio quotidiano: mentre il piccone intacca le placche gelate e la prua della nave infrange la banchisa, c’è chi rompe il ghiaccio nel tentativo di vincere un’iniziale freddezza e avviare un rapporto umano più disteso e sereno.
Il corteggiatore, simulando disinvoltura, cerca di rompere il ghiaccio con una battuta per far colpo sulla bella sconosciuta; l’oratore, per accattivarsi la simpatia di un uditorio diffidente, si mostra informale e spontaneo; in treno, per rompere il ghiaccio, in molti esprimono commenti sul clima e sulle mezze stagioni che, lo sanno tutti, oramai non esistono più.
L’Accademia della Crusca, sempre autorevole e prodiga di informazioni, registra l’uso della locuzione “rompere il ghiaccio” da parte del Petrarca nel Trecento, del Poliziano nel Quattrocento e del Manzoni, nei Promessi Sposi, nell’Ottocento. Anche Giosuè Carducci ricorre a questo classico modo di dire, ma nell’accezione di agevolare un percorso, facilitare il raggiungimento di uno scopo, proprio come fa la prua della nave rompighiaccio tracciando faticosamente la propria rotta.
È possibile addirittura che le radici della locuzione affondino nella lingua latina nella quale, scindere glaciem, si riferiva alla rottura del ghiaccio dei canali da parte dei barcaioli. Di certo l’efficacia di questo colorito modo di dire è stata tale da influenzare i cugini d’oltralpe, che nel Seicento si sono finalmente convinti a rompre la glace, e ancor prima gli inglesi i quali, capeggiati da Shakespeare, già dal Cinquecento, padroneggiano l’arte del “break the ice”.
Se per l’individuo sicuro di sé, ardito e temerario, rompere il ghiaccio non è un problema, per il timido può rappresentare una difficoltà insormontabile, una prova talmente ardua da spingere addirittura alla rinuncia, specie se si tratta di affari di cuore. A questo proposito lo scrittore Roberto Gervaso ricordava un tizio talmente timido che, quando suonava un campanello, sperava che nessuno aprisse la porta.
(Autore: Marcello Marzani)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata