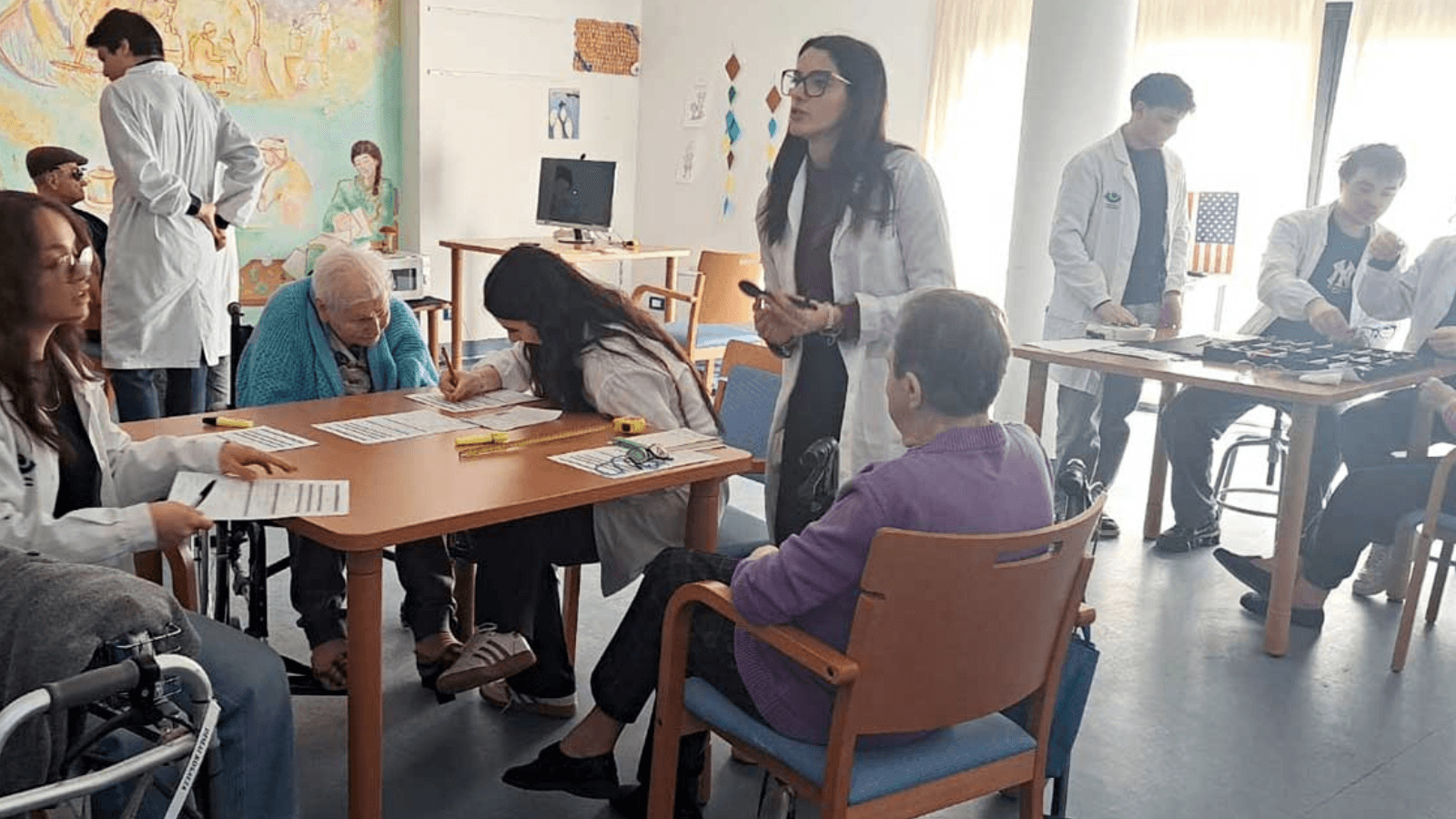C’è stato un tempo in cui le parole avevano peso. Quando si diceva “foresta” non si intendeva la stessa cosa di quando si pronunciava “selva” che non a caso era spesso “oscura”, e un “bosco” era qualcosa di ancora diverso. Non si trattava di vezzi linguistici: queste distinzioni rivelavano modi differenti di percepire e abitare il rapporto con gli spazi “vegetali”. La lingua rifletteva un’esperienza vissuta, corporea, emotiva di questi luoghi. Oggi usiamo questi termini come fossero fungibili, rivelando quanto sia diventato superficiale il nostro legame con questi ecosistemi.
Quella capacità di distinzione è andata perduta insieme a qualcosa di più profondo: il senso di soglia. Per millenni, addentrarsi tra gli alberi significava lasciare il mondo ordinato dell’agricoltura e dell’abitato per entrare in un dominio governato da altre logiche. Erano luoghi altri rispetto agli spazi controllati dall’uomo, e questo generava rispetto, a volte timore, sempre consapevolezza di trovarsi in territorio straniero. Per secoli, immergersi in una grande distesa alberata ha significato confrontarsi con l’ignoto, con ciò che sfugge al controllo umano. Era un’esperienza che lasciava il segno, che poteva cambiare chi la viveva.
Cosa ne abbiamo fatto di questa eredità? L’atteggiamento contemporaneo nei confronti degli spazi naturali è pervaso da un antropocentrismo che pretende di piegare ogni ambiente alle esigenze umane. Un bosco deve essere “fruibile”, dicono amministratori e progettisti. Sentieri ben segnalati, cartelli esplicativi, indicazioni precise. Nulla lasciato al caso, nessun mistero. L’idea di fondo è che basti penetrare in una foresta per diventare cittadini consapevoli.
La realtà è l’opposta: trasformiamo le foreste in parchi tematici dove ogni elemento è etichettato, i percorsi livellati anche per calzature inadeguate, pannelli informativi che risparmiano a chiunque lo sforzo di osservare davvero. Pretendiamo che questi luoghi si adattino alle nostre abitudini urbane invece di accettare la sfida di adattarci noi alle loro regole. E la foresta addomesticata perde proprio ciò che la rendeva preziosa: la sua alterità radicale.
Ma c’è un problema ancora più profondo, che riguarda il modo stesso in cui concepiamo questi ecosistemi. Parliamo di foreste come se fossero cataloghi di specie vegetali, elenchi di alberi più o meno pregiati, magari con qualche dato sulla composizione del suolo e sull’esposizione. Questa visione riduzionista e meccanicistica, eredità di un approccio cartesiano alla natura, dimentica sistematicamente una componente essenziale: gli animali.
Una foresta senza fauna non è una foresta. È un’astrazione, una semplificazione che esiste solo nei manuali scritti male. Nella realtà, ogni bosco è una biocenosi complessa dove vegetazione e fauna sono indissolubilmente legate. I cervi che brucano le gemme influenzano la struttura del sottobosco. I caprioli selezionano determinate specie vegetali favorendone o limitandone la diffusione. I cinghiali rivoltano il terreno modificando la composizione della lettiera. I grandi predatori regolano le popolazioni di erbivori, impedendo che la pressione sulle piante diventi eccessiva. Senza questa rete di relazioni, senza questo intreccio di vite che si influenzano reciprocamente, non esiste alcun ecosistema forestale degno di questo nome.
Eppure la selvicoltura tradizionale continua a considerare gli animali un problema. Il cervo “danneggia” il bosco coltivato. Il capriolo è tollerato perché meno impattante. Della fauna si vorrebbe fare a meno, perché complica la gestione, rende imprevedibili i risultati, disturba i piani razionali dell’uomo che vuole controllare ogni variabile.
Questa visione non deriva necessariamente da mancanza di preparazione. È piuttosto la conseguenza di un paradigma che vede il bosco come una risorsa da gestire secondo criteri produttivi, dove gli alberi sono materia prima e tutto il resto è contorno. In questa logica, un ungulato che scorteccia una pianta pregiata è semplicemente un fattore negativo da eliminare. Che quello stesso ungulato contribuisca alla dispersione di semi, alla creazione di radure che favoriscono la biodiversità, all’innesco di processi di rigenerazione dinamici, conta poco o nulla.
La conseguenza di questa cecità è grottesca: gestiamo foreste che sulla carta sono perfette ma che in realtà sono ecosistemi impoveriti, semplificati, privati dei meccanismi di autoregolazione che li hanno fatti funzionare per decine di millenni. Crediamo di sapere meglio della natura come deve essere un bosco, e il risultato sono monocolture arboree fragili, dipendenti dall’intervento umano costante, incapaci di resistere agli stress ambientali, come purtroppo siamo in grado di constatare.
E gli “ecoturisti”? Vogliono vedere gli animali, ma preferibilmente addomesticati, prevedibili, fotografabili in condizioni comode. L’idea che incontrare la fauna selvatica richieda pazienza, silenzio, fatica è incompatibile con la logica della fruizione organizzata. Si pretendono capanni fotografici ben posizionati, orari garantiti per l’avvistamento. È la logica del safari in riserva privata: gli animali devono esserci, essere visibili, comportarsi in modo sufficientemente interessante. La loro selvatichezza diventa performance da consumare, non condizione esistenziale da rispettare.
Il punto non è negare l’accesso agli spazi naturali. Il punto è capire che questo godimento non può avvenire alle condizioni dettate dalla civiltà urbana. Dovrebbe richiedere sforzo, preparazione, disponibilità a confrontarsi con l’imprevedibile.
La presenza degli animali selvatici è parte integrante di questa esperienza. Un bosco vero è abitato da creature che non ci appartengono, che non rispondono ai nostri comandi, che seguono i loro ritmi e le loro esigenze. Il cervo che attraversa una radura all’alba, il capriolo che osserva immobile tra i cespugli, il cinghiale che grufola nella lettiera: sono loro i veri abitanti di questi luoghi, non noi. Noi siamo ospiti, visitatori temporanei in un mondo che esisteva prima di noi e continuerà ad esistere dopo.
Forse è proprio questo che abbiamo dimenticato: la foresta non è la casa dell’uomo. È disumana, nel senso più profondo del termine. E tale deve tornare ad essere se vogliamo che continui a svolgere le sue funzioni ecologiche, ma anche quella funzione formativa che aveva per le generazioni passate.
Pensate alla differenza tra camminare in un bosco silenzioso, attenti a ogni rumore, scrutando tra i tronchi nella speranza di scorgere un movimento, consapevoli che potreste imbattervi in un branco di cinghiali o sorprendere un capriolo al pascolo, e percorrere invece un sentiero natura attrezzato, con tanto di corrimano e pannelli esplicativi, dove l’unica fauna che incontrerete sarà quella immortalata nelle fotografie plastificate. Nel primo caso state facendo un’esperienza di natura. Nel secondo state visitando un museo all’aperto.
Servirebbe una nuova pedagogia del bosco, basata non sulla facilitazione ma sulla sfida. Sentieri meno evidenti, cartellonistica ridotta al minimo, spazi dove sia possibile perdersi almeno un po’. Dove è necessario rallentare, osservare, prestare attenzione. Dove gli animali possano vivere senza essere continuamente disturbati.
Questo significa ripensare le modalità di accesso con gradualità: aree periferiche più accessibili per chi cerca una passeggiata facile, e poi progressivamente zone dove l’accesso diventa più impegnativo, i sentieri meno evidenti, la segnaletica diradata. E infine nuclei dove l’uomo entra solo per monitoraggio scientifico, lasciando alla foresta e ai suoi abitanti la possibilità di esistere senza interferenze continue.
È un modello che richiede coraggio politico, perché va contro la tendenza a democratizzare l’accesso ovunque. Ma la vera democrazia ambientale non è dare a tutti lo stesso facile accesso: è garantire che esistano ancora ecosistemi funzionanti per le generazioni future.
Per un ordinario approccio selvicolturale, questo significa accettare che una foresta gestita non è una piantagione, che gli animali non sono un problema ma una componente essenziale, che il “disordine” naturale è la condizione normale di un sistema complesso e vitale. Per gli ecoturisti, significa capire che la vera esperienza della natura richiede umiltà, non comfort, e che forse tornerete a casa senza aver visto nessun animale.
Riportare il mistero nei boschi non significa oscurantismo: significa riconoscere che la complessità di un ecosistema forestale non può essere ridotta a pannelli informativi. Gli animali sono i protagonisti di questa complessità, i nodi di una rete di relazioni così intricata che ne comprendiamo solo una parte. Il lupo che caccia il cervo, modificando i pattern di pascolo. La lince che seleziona le prede, influenzando le popolazioni di ungulati. Ogni creatura trasforma una collezione di alberi in un organismo pulsante.
Solo così, forse, potremo tornare a capire davvero cosa significhi sostenibilità. Non come slogan da marketing, ma come pratica concreta di rispetto per ecosistemi di cui siamo parte, non padroni. E dove gli altri abitanti hanno tanto diritto di esistere quanto noi.
Qualcuno dirà che tutto questo è impossibile in un paese come il nostro. In Italia non esistono intere foreste vergini, ogni centimetro di territorio porta i segni della manipolazione umana, millenni di utilizzo hanno plasmato anche i boschi più remoti. È vero. Ma è precisamente questa la sfida più interessante.
Non si tratta di tornare a una natura primordiale che non esiste più. Si tratta di avere la consapevolezza che anche in un paesaggio profondamente antropizzato possiamo scegliere di restituire spazio alla selvatichezza.
Serve consapevolezza: capire che la fruizione facile non è un diritto ma una concessione che ha un costo ecologico. Serve volontà: quella di amministratori disposti a dire no a progetti che facilitano l’accesso a discapito della funzionalità degli ecosistemi. Serve coraggio politico: quello necessario per spiegare ai cittadini che alcune limitazioni non sono ostacoli alla loro libertà ma investimenti sul futuro.
L’Italia ha plasmato i suoi paesaggi per secoli, è vero. Ma questo non significa che non possa fare una scelta diversa per i secoli a venire. Anzi: forse proprio perché abbiamo manipolato così tanto, abbiamo la responsabilità di restituire. Non tutto, non ovunque. Ma abbastanza da garantire che le prossime generazioni possano ancora entrare in un bosco e sentirsi, almeno un po’, stranieri.
È possibile. Basta volerlo.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata