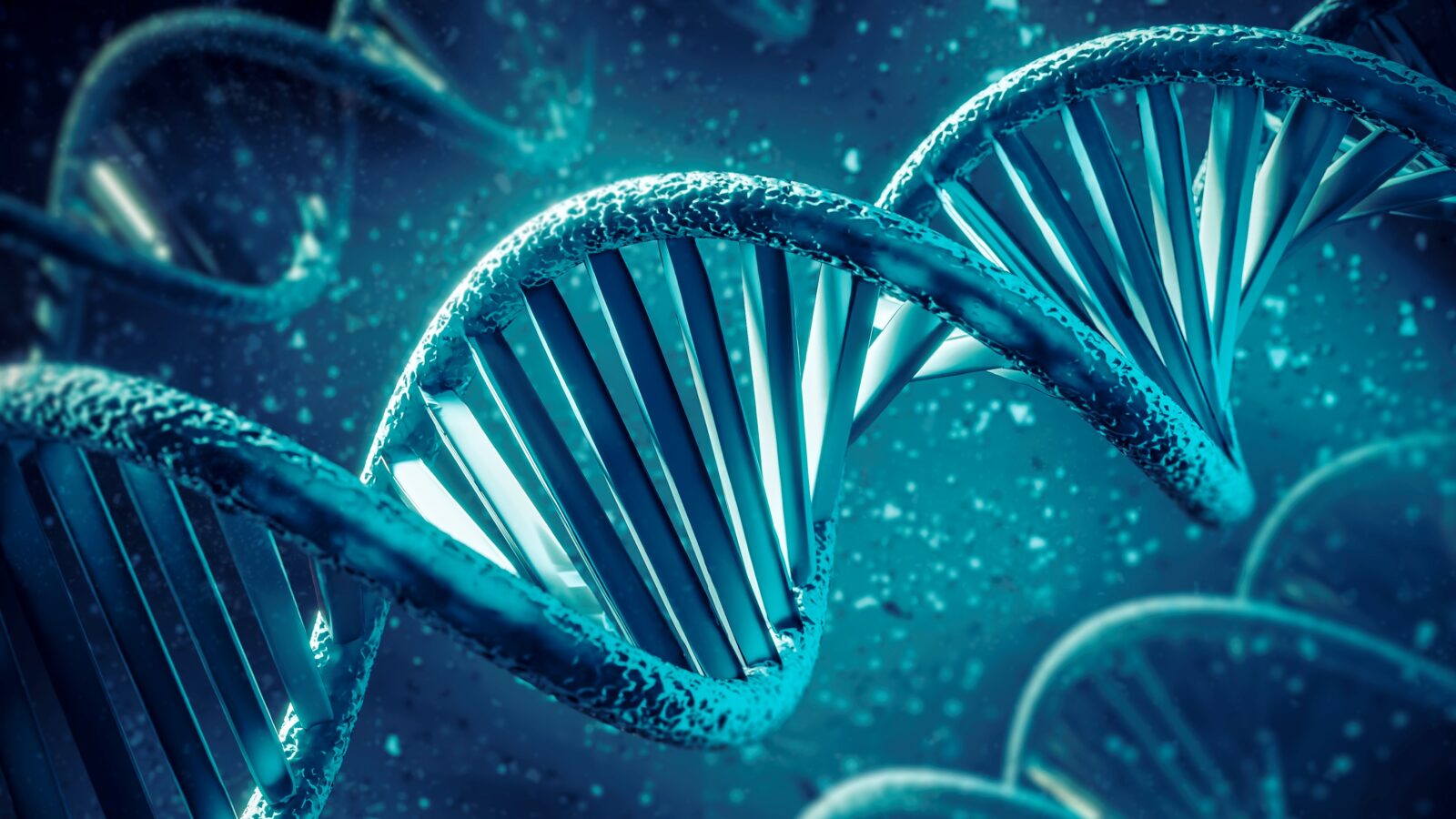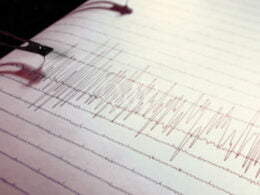Ad Abu Dhabi, nel 2025, qualcosa di storico è accaduto. Qui la notizia. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha fatto una scelta che molti consideravano inevitabile, ma che pochi si aspettavano sarebbe arrivata così presto: aprire la porta alla biologia sintetica come strumento di conservazione. Con l’88% dei voti favorevoli, governi, ONG e organizzazioni di popolazioni indigene hanno adottato la Mozione 87, la prima politica globale che tenta di dare un senso a questa tecnologia rivoluzionaria e controversa.
La decisione non è stata presa a cuor leggero. Per capirla, bisogna immaginarsi nella stanza dove tutto è successo: da una parte c’era la Mozione 133, che chiedeva una moratoria totale sulle specie selvatiche geneticamente modificate, cioè organismi che vivono in natura il cui DNA viene modificato deliberatamente e poi rilasciato negli ecosistemi. Dall’altra la Mozione 87, che proponeva un approccio diverso, più sfumato, più coraggioso, forse. I membri dell’IUCN hanno scelto, come hanno detto i sostenitori, “la speranza sulla restrizione, l’evidenza sulla paura e la collaborazione sulla divisione”. In un’epoca in cui oltre un milione di specie rischiano l’estinzione, hanno deciso che non potevano permettersi di chiudere nessuna porta.
Ma cos’è esattamente questa biologia sintetica di cui tutti parlano? La Convenzione sulla Diversità Biologica la definisce come un ulteriore sviluppo della biotecnologia moderna, che combina scienza, tecnologia e ingegneria per progettare e modificare materiali genetici e organismi viventi. Sembra complicato, e lo è. Ma nella sua essenza è qualcosa di potente: la capacità di ripristinare ciò che abbiamo perduto, di eradicare invasori che stanno distruggendo ecosistemi interi, di costruire resilienza in specie che altrimenti non sopravviverebbero al cambiamento climatico.
Pensiamo a esempi concreti: modificare geneticamente una popolazione di coralli per renderla resistente all’acidificazione degli oceani e alle temperature più elevate, salvandola dall’estinzione. Oppure usare i cosiddetti “gene drive” per controllare topi o ratti invasivi su isole remote, modificando il loro DNA in modo che, generazione dopo generazione, nascano sempre più maschi e sempre meno femmine, fino all’estinzione locale della popolazione che sta devastando gli ecosistemi nativi. O ancora, ripristinare diversità genetica perduta in specie ridotte a poche centinaia di individui, dando loro una chance di sopravvivenza che altrimenti non avrebbero. Thomas Brooks, Chief Scientist dell’IUCN, ha sottolineato che questa tecnologia sta avanzando rapidamente, e con essa crescono le sue implicazioni per la conservazione della natura.
Eppure c’è l’altro lato della medaglia, quello che tiene svegli la notte molti scienziati ed ecologisti. Cosa succede se modifichiamo una specie e questa cambia l’equilibrio di un intero ecosistema? Cosa succede se gli effetti si ripercuotono su specie che non erano nemmeno il nostro obiettivo? E se le colture geneticamente modificate iniziassero a crescere in luoghi dove prima non potevano, spingendosi in aree naturali e aggravando proprio quella perdita di biodiversità che volevamo combattere? Questi non sono scenari di fantascienza, sono rischi concreti che la politica dell’IUCN riconosce apertamente.
Ed è proprio qui che la Mozione 87 si distingue. Non dice né sì né no alla biologia sintetica. Come ha spiegato Maria Julia Oliva, che ha co-presieduto il gruppo di lavoro che ha sviluppato la politica, questo documento è importante per tre ragioni fondamentali: dà nuova speranza per salvare specie che affrontano minacce ancora ingestibili, garantisce che ogni applicazione proceda con un approccio precauzionale, e richiede che anche gli altri settori, dall’agricoltura all’industria, tengano conto della conservazione quando usano queste tecnologie.
Il cuore della politica è un meccanismo di valutazione caso per caso. Ogni proposta di utilizzare la biologia sintetica dovrà essere esaminata separatamente, pesando rischi e benefici con rigore scientifico ma anche considerando altri sistemi di conoscenza, in particolare le conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene. Qui entra in gioco il principio di precauzione della Dichiarazione di Rio del 1992, insieme a quello che potremmo chiamare il principio del dubbio a favore della natura: quando non siamo sicuri, proteggiamo la vita.
Ma c’è qualcosa di ancora più significativo in questa politica, ed è il modo in cui è nata. Per la prima volta nella sua lunga storia, l’IUCN ha convocato un’Assemblea dei Cittadini, composta da rappresentanti di 15 membri dell’organizzazione, bilanciati geograficamente, tra governi e società civile, tra uomini e donne. Bibiana Sucre, consigliera IUCN dal Venezuela, ha raccontato come questi partecipanti abbiano seguito un corso di formazione intensivo e poi deliberato per un’intera settimana, producendo 80 raccomandazioni che hanno plasmato la politica finale. Questo è stato solo l’inizio: sono seguiti webinar, consultazioni con forum regionali, comitati, commissioni, e poi due cicli completi di revisione che hanno generato oltre 800 commenti. Persino la Convenzione sulla Diversità Biologica ha partecipato come osservatore.
Non tutti però sono rimasti soddisfatti. Alcune organizzazioni non governative hanno sollevato preoccupazioni sul processo, parlando di possibile parzialità, problemi di trasparenza, dubbi sul fatto che le popolazioni indigene e le comunità locali di tutte le regioni abbiano davvero avuto voce in capitolo. Queste critiche non vanno ignorate, perché toccano il nervo scoperto di ogni grande decisione che riguarda il futuro del pianeta: chi ha il diritto di decidere?
La risposta dell’IUCN è chiara, almeno sulla carta. La politica stabilisce che le popolazioni indigene e le comunità locali devono dare il loro Consenso Libero, Previo e Informato prima di qualsiasi applicazione che le riguardi, in linea con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. Non solo: i principi di accesso e condivisione dei benefici si applicano anche alle informazioni sulle sequenze digitali, quelle stringhe di dati genetici che sono alla base dello sviluppo di organismi sintetici.
Il Professor Zabta Shinwari, membro della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie dell’IUCN, ha messo in evidenza un aspetto cruciale che rischia di passare inosservato: tutto questo richiede formazione e capacità tecniche. Non basta scrivere una bella politica se poi le comunità più colpite dalla perdita di biodiversità non hanno gli strumenti per comprendere, valutare, partecipare davvero alle decisioni. La politica incoraggia quindi programmi di capacity building accessibili, che includano formazione per il monitoraggio e le valutazioni d’impatto.
Ciò che rende questa politica ancora più ambiziosa è la sua portata. Non si limita alle applicazioni dirette per la conservazione, ma guarda anche agli altri settori: industria, agricoltura, medicina. Ovunque la biologia sintetica venga utilizzata, se ci sono potenziali impatti sulla natura, questa politica dice che le preoccupazioni per la conservazione devono essere incorporate. È una visione olistica che riconosce una verità scomoda: non possiamo più separare la conservazione dal resto delle attività umane.
Ora l’IUCN invita tutti i suoi costituenti a seguire questa politica e raccomanda alle parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, della CITES e di altri accordi internazionali di tenerne conto. Ma la sfida vera inizia adesso. In un mondo dove non esiste ancora un quadro legale internazionale che regoli in modo completo la biologia sintetica, questa politica diventa una bussola in un territorio inesplorato. L’implementazione richiederà trasparenza continua, partecipazione reale, monitoraggio rigoroso, e soprattutto la volontà di imparare e adattarsi lungo il percorso.
Ad Abu Dhabi, la comunità della conservazione ha fatto una scelta che alcuni chiameranno pragmatica, altri temeraria. Ha scelto di non chiudere la porta all’innovazione per paura, ma nemmeno di spalancarla incautamente. Ha scelto di camminare lungo una linea sottile tra speranza e prudenza, guidata dalla scienza, dall’etica e dal rispetto per coloro che da sempre custodiscono la biodiversità del pianeta. Di fronte a una crisi senza precedenti, forse questa è esattamente la saggezza di cui abbiamo bisogno: il coraggio di esplorare nuove possibilità senza dimenticare le lezioni del passato, la capacità di innovare senza perdere l’umiltà di fronte alla complessità della vita.
Il tempo dirà se questa scelta è stata giusta. Ma una cosa è certa: il mondo della conservazione non sarà più lo stesso.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata