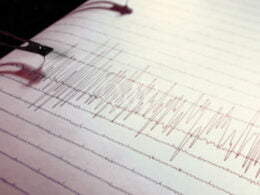Immaginate di camminare tra le colline trevigiane in una giornata di sole e di trovarvi faccia a faccia con una zigena della filipendola, una piccola farfalla dai colori sgargianti, nero-bluastro e rosso vivo, che sembra quasi volervi urlare: “Non mangiarmi!”. Poco più in là, su un terreno sassoso, c’è una cavalletta italiana dalle tonalità marroni e grigiastre, così perfettamente mimetizzata con il suolo che quasi non la notate. Due creature, due strategie completamente opposte per affrontare lo stesso problema: sopravvivere agli attacchi dei predatori.
Il mondo animale è un caleidoscopio di colori, ma dietro questa palette cromatica si nasconde una partita di sopravvivenza giocata da milioni di anni. La maggior parte degli animali punta tutto sul camuffamento, avvolgendosi in pattern che li rendono quasi invisibili ai predatori. Altri invece fanno esattamente l’opposto: si vestono con colori accesi e audaci per avvertire i potenziali nemici che non sono un buon pasto. Questa seconda strategia ha un nome scientifico che suona quasi musicale: aposematismo, ovvero la colorazione di avvertimento. Anche se meno comune del camuffamento, l’aposematismo si è evoluto centinaia di volte in farfalle, scarafaggi, insetti vari, nudibranchi marini, rane velenose e persino in alcuni uccelli.
Ma perché alcune specie scelgono una strada e altre l’opposta? Quale delle due strategie funziona meglio? E soprattutto, in quali circostanze specifiche una batte l’altra? Sono domande che gli scienziati si pongono da tempo, e finalmente abbiamo alcune risposte concrete grazie a uno studio monumentale che ha coinvolto ricercatori di sedici paesi diversi sparsi su sei continenti che potete leggere qui.
Prendiamo l’Australia come esempio. Qui convivono felicemente sia animali mimetizzati che creature dai colori sgargianti. Ci sono le katididi predatorie macchiate, insetti simili a cavallette che sembrano foglie viventi con macchie bianche e verdi, e i ragni del lichene, maestri indiscussi del camuffamento. Dall’altra parte troviamo la cimice arlecchino del cotone, un insetto puzzolente comune nelle aree urbane, e la falena handmaiden, che sfoggiano colori arancioni e rossi brillanti per comunicare ai predatori che rappresenterebbero una cena decisamente sgradevole. Alcune specie più furbe, come le katididi di montagna, usano addirittura entrambe le strategie, cambiando colore o nascondendo e rivelando macchie colorate a seconda delle necessità.
Esistono dozzine di teorie sul perché alcune specie siano mimetizzate mentre altre preferiscano i colori di avvertimento, e districarsi tra tutte queste idee è una sfida enorme. Studi localizzati e di piccole dimensioni hanno provato a testare l’effetto di diversi fattori separatamente. Sappiamo, per esempio, che i livelli di luce sono importanti per il successo delle strategie di camuffamento. Sappiamo anche che l’efficacia dei colori di avvertimento dipende spesso dal fatto che i predatori abbiano già incontrato quella preda in precedenza e abbiano imparato a evitare quei segnali di pericolo. Ma cosa conta di più: la luce o la capacità di apprendimento del predatore? E poi, i risultati ottenuti in un singolo luogo valgono solo per quel posto specifico, mentre vediamo le stesse strategie applicate in tutto il mondo. Funzionano allo stesso modo ovunque?
Per risolvere questo mistero, un grande team internazionale di collaboratori ha deciso di fare qualcosa di mai tentato prima: eseguire lo stesso identico esperimento in sedici paesi diversi, in foreste con livelli di luce differenti e con comunità di prede e predatori diverse. Hanno dispiegato oltre quindicimila prede artificiali, delle falene di carta con tre diverse colorazioni: il classico pattern di avvertimento arancione e nero, un sobrio marrone che si mimetizza perfettamente, e un insolito blu e nero molto vistoso. Ogni bersaglio di carta era imbottito con un verme della farina, che permetteva di misurare la sopravvivenza di ogni tipo di colorazione. Se l’esca veniva presa, i ricercatori assumevano che un predatore avesse deciso di consumare quel bersaglio.
Il tipico colore di avvertimento rappresentava la combinazione arancione e nero ampiamente diffusa che vediamo in molti animali tossici, come la farfalla monarca e le rane velenose. Il colore di avvertimento insolito corrispondeva a un pattern meno utilizzato ma comunque molto visibile, simile alla farfalla di Ulisse. Avere queste due colorazioni di avvertimento permetteva di testare se i predatori evitano il segnale arancione e nero perché è familiare o semplicemente perché è molto visibile.
I risultati sono stati sorprendenti nella loro complessità. Non esiste una strategia “migliore” in assoluto. Invece, i predatori locali, le prede locali e la luce della foresta contribuiscono tutti a determinare se il camuffamento o i colori di avvertimento offrano maggiore protezione. I predatori presenti nella comunità e l’intensità con cui attaccano le prede hanno avuto l’impatto più grande su quale colore fosse più efficace nell’evitare gli attacchi. Nei luoghi dove c’erano molti attacchi di predatori, dove la competizione per il cibo è probabilmente intensa, i predatori sono più propensi ad attaccare prede che sembrano pericolose o sgradevoli. Questo significa che il camuffamento era più protettivo nelle aree con molta predazione.
Ma le prede mimetizzate non riuscivano a nascondersi altrettanto bene in ogni ambiente. Per esempio, in ambienti ben illuminati, i benefici del camuffamento andavano persi, mentre le condizioni di luce non influenzavano le prestazioni delle prede arancioni e nere. La familiarità con le prede era anch’essa importante. Nei luoghi dove le prede mimetizzate sono abbondanti, nascondersi era meno efficace, poiché i predatori probabilmente imparano a trovare le prede camuffate.
D’altra parte, nei luoghi dove i colori di avvertimento erano comuni, i predatori erano più bravi a evitare il segnale di avvertimento tipico, ma non quello atipico. Questo suggerisce che i predatori imparano a evitare i segnali di avvertimento familiari, il che aiuta a spiegare perché così tanti animali condividono combinazioni di colori simili. Pensate alle farfalle monarca, nere, arancioni e bianche, un avvertimento netto per qualsiasi uccello nelle vicinanze che si senta un po’ affamato. Quelli che decidono comunque di dare un morso imparano presto la lezione: le farfalle hanno tossine nel loro sistema che le rendono disgustose e non digeribili per gli uccelli, che vomitano dopo aver tentato di mangiare questo pasto sgradevole. Nel frattempo, animali come il serpente reale di montagna dell’Arizona non sono velenosi, ma la loro colorazione ricorda quella dei serpenti velenosi, nel tentativo di ingannare i predatori e convincerli a stare alla larga.
Lo studio dimostra come molteplici caratteristiche dell’ambiente determinino quale strategia sia più protettiva. Mostra anche che il successo delle strategie di camuffamento potrebbe dipendere maggiormente dal contesto ecologico rispetto a quello dei segnali di avvertimento. E questa scoperta ha implicazioni profonde per il futuro. Man mano che il cambiamento climatico trasforma gli habitat, le condizioni vitali per il successo delle diverse strategie antipredatorie possono cambiare anch’esse.
Per esempio, le strategie di camuffamento potrebbero andare peggio in habitat trasformati che hanno poca copertura vegetale e alti livelli di luce. In un mondo che si sta rapidamente modificando a causa delle attività umane e del clima, capire questi meccanismi diventa fondamentale. Le scoperte di questo studio possono aiutarci a prevedere meglio l’effetto che questi cambiamenti potrebbero avere sugli animali che usano diverse strategie cromatiche contro i predatori, e a prendere misure per mitigarne l’impatto.
La prossima volta che vi imbatterete in un insetto dai colori vivaci o che farete fatica a individuare una falena perfettamente mimetizzata, ricordatevi che state assistendo al risultato di milioni di anni di evoluzione, a una partita a scacchi giocata tra prede e predatori dove ogni mossa conta e dove non esiste una strategia vincente universale. Ogni ambiente, ogni comunità di predatori, ogni livello di luce racconta una storia diversa su come sopravvivere nel grande teatro della natura.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata